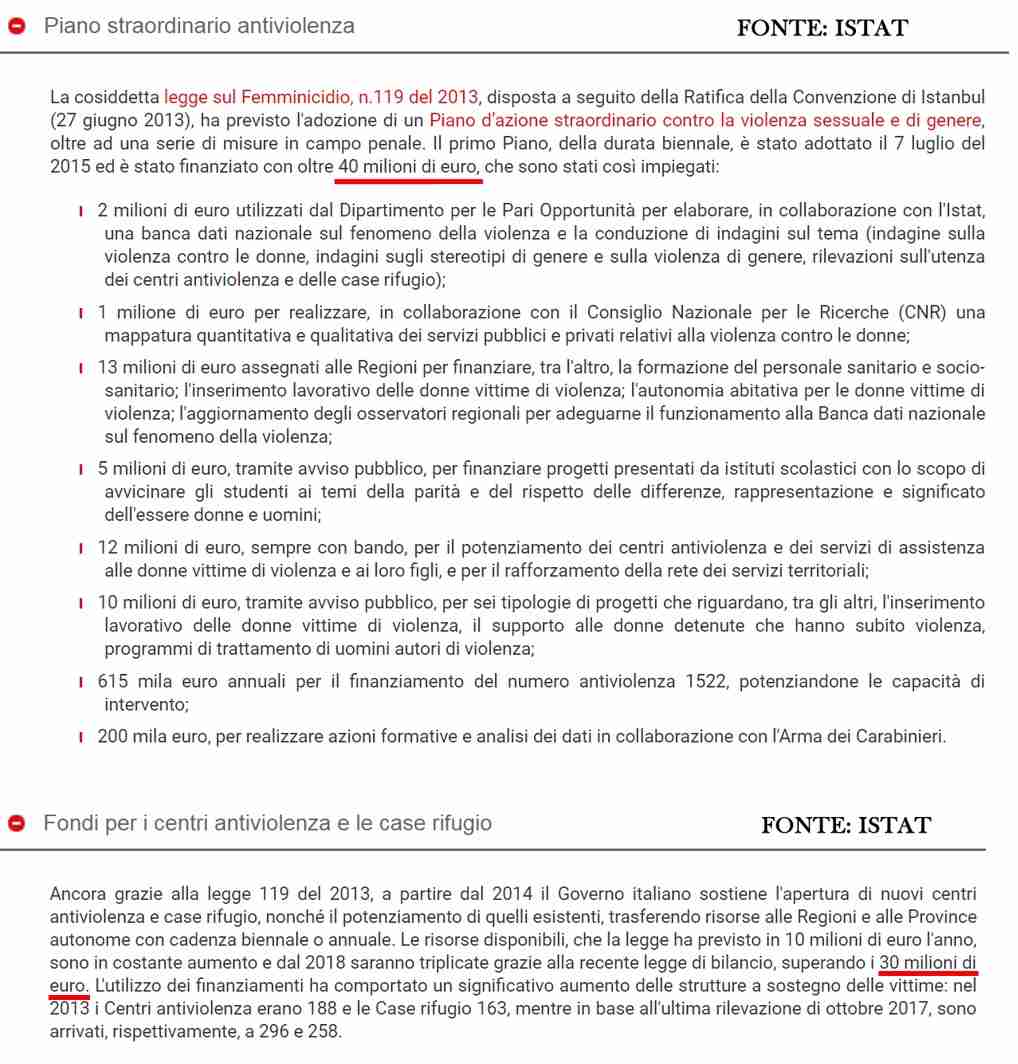È piuttosto nota, per lo meno a chi ci legge con costanza, la nostra posizione ostile ai centri antiviolenza. Un’ostilità di principio, riassumibile nel dato di fatto che l’anomalia che essi sarebbero chiamati ad affrontare e correggere, la violenza contro le donne, ha in Italia dimensioni tali da non giustificare la capillare diffusione di queste forme associative e il loro non indifferente potere d’influenza, specie quando riunite sotto specifici coordinamenti (come D.I.Re.). Non solo: la loro azione è spesso distruttiva. Fin dalla loro nascita i centri antiviolenza si sono distinti in molti casi per aver indotto donne alla denuncia falsa o strumentale, per essere diventati centrali di propaganda politica e ideologica più che sportelli di servizio, e in ultimo per essere diventati agenti di disturbo all’interno di delicati procedimenti civili (separazioni) o penali, con i loro tentativi, spesso coronati da successo, di costituirsi parte civile per raccattare ancora più denaro di quanto già non ricevano regolarmente dallo Stato in tutte le sue articolazioni. Tutti aspetti di cui a più riprese abbiamo parlato, ma è su quest’ultimo, l’aspetto economico che vorremmo qui soffermarci.
Qualche punto fermo: nella stragrande maggioranza dei casi i centri antiviolenza vengono gestiti da soggetti associativi, raramente da cooperative. La differenza è sostanziale: le associazioni sono per legge entità “leggere”, poco o punto tassate, esentate da ogni obbligo gravante su forme giuridiche più vincolanti come appunto le cooperative o più ancora le aziende. Esistono leggi sulla trasparenza e sulla responsabilità penale delle società, norme antimafia e anticorruzione, e dispositivi che rendono obbligatoria la pubblicità dei bilanci. La conformità a queste norme è spesso condizione preliminare per poter partecipare a bandi di affido lavori pubblicati dalle pubbliche amministrazioni, a riprova della loro importanza. Tuttavia si tratta di restrizioni da cui un’associazione è sollevata. Per questo molti utilizzano quella forma giuridica per fare piccoli o grandi business sottratti ad ogni controllo. Teoricamente, ad esempio, un’associazione non può fare utili e i suoi i soci non possono attribuirsi stipendi per ripagare le loro attività, tuttavia ogni associazione può avere il suo “fondo cassa” e da esso i soci possono ritirare le risorse necessarie come “rimborso spese”, senza che nessuno, nemmeno le autorità preposte, possa sindacare.
Difficile che girino cifre inferiori.
Ebbene, contro ogni logica gestionale e non di rado in deroga al codice degli appalti, le associazioni che gestiscono i centri antiviolenza ricevono da enti pubblici di ogni ordine e grado (Stato, Regioni, Comuni) ruoli suppletivi e relative risorse. L’idea di base è che lo Stato non sia in grado, con le sue strutture, di affrontare il fenomeno della violenza contro le donne, dunque esternalizza l’attività, affidandola a privati che agiscano in sua vece e in suo nome, e che poi si relazionino con le autorità nei casi dovuti. Nel farlo, però, ed è la prima grande anomalia, si rivolge al mondo associazionistico, a cui non può legalmente chiedere il rispetto di tutti quei requisiti che valgono invece per cooperative o aziende. In sostanza, la presenza di numerosissime associazioni dedite all’antiviolenza e a fare lobby induce gli enti pubblici ad affidare all’esterno importanti funzioni senza le garanzie richieste ad altre tipologie di soggetti su temi come la trasparenza, la responsabilità penale, l’antimafia, l’anticorruzione e la pubblicità di atti e bilanci. Un’indulgenza che potrebbe essere accettabile per associazioni sportive dilettantistiche o con un oggetto sociale tutto sommato non “critico”, ma che non può e non dovrebbe valere per entità chiamate a sostituire e rappresentare lo Stato nella cruciale funzione di fare da sportello per i casi di violenza domestica o di genere. Eppure questo accade: lo Stato svende un proprio importante ruolo a entità con una forma giuridica impalpabile e incontrollabile.
Esiste, è vero, una normativa che regolamenta tutto quanto. Si tratta di un accordo Stato-Regioni del 2015 che dà qualche indicazione di massima, stabilisce maglie larghissime, che si restringono solo su alcuni punti: gli operatori dei centri antiviolenza devono essere soltanto donne (senza altri requisiti di base legati alle competenze) ed essi devono accogliere soltanto donne. Così è, si dice, perché così stabilisce la Convenzione di Istanbul. Ma è una mistificazione: la Convenzione parla anche di generica “violenza domestica”, di cui chiunque, uomo o donna, potrebbe essere vittima. Un tema che la disciplina italiana dei centri antiviolenza ha volutamente rimosso, per supportare al meglio il principio ideologico che sta alla base stessa della Convenzione di Istanbul e dell’esistenza dei centri antiviolenza: le vittime sono solo donne e i carnefici sono sempre uomini. A questo apparato, che, stanti queste condizioni di vantaggio, si è in breve moltiplicato a dismisura (i centri antiviolenza in Italia oggi sono più di 350), lo Stato mette anche a disposizione le risorse per operare. Tempo fa si trattava di un dato messo in chiaro, ne dava informazione trasparente l’ISTAT qualche anno fa (vedi immagine sottostante), quantificando il giro d’affari in circa 70 milioni di euro annui in commesse dirette (incalcolabili quelle indirette). Ora niente di così preciso viene più pubblicato in merito e le spettanze vengono fatte pervenire per diverse vie, direttamente da Roma o tramite gli enti locali, cosicché risulta ormai impossibile quantificare quanto denaro pubblico fluisca ai centri antiviolenza. Difficile in ogni caso, con il battage propagandistico che si fa sulla presunta “dilagante” violenza contro le donne, che girino cifre inferiori a quelle individuate in passato.
La doppia rapina dei centri antiviolenza.
Ma, ed è questa la domanda centrale, che fine fanno quei soldi? Il nostro sospetto, da sempre, era che finissero in tre tasche diverse, più una. La prima è quella delle socie, tramite il trucco del “rimborso spese”. La seconda tasca è quella delle dipendenti (quando ci sono), sotto forma di regolare stipendio. La terza tasca è quella delle attività di propaganda a carattere femminista (brochure, manifesti, convegni, eventi et similia). Tre destinazioni direttamente riscontrabili. Più una quarta invisibile, probabilmente destinata a circuiti politici d’appoggio o a personaggi politici di protezione. Corruzione? Sì, questa è la nostra ipotesi, come tale, lo ammettiamo, non dimostrabile; o meglio: dimostrabile solo da un magistrato, se ne esistesse qualcuno ardimentoso abbastanza da mettere il naso nella questione. Le prime tre questioni invece dimostrabili lo sono. Tramite un nostro affezionato lettore che lavora in una banca del centro Italia, siamo riusciti a buttare un occhio attento ai movimenti bancari degli ultimi sei mesi di un importante centro antiviolenza di medie dimensioni, cosa che ha trasformato i nostri sospetti in certezza. Giacenza: oscillante tra i 125 e i 127 mila euro. Entrate: alcuni contributi privati (le cosiddette “donazioni”, cioè probabilmente percentuali che le donne persuase dal centro antiviolenza a intentare una causa vengono invitate a versare in caso di ottenimento di risarcimenti) e “tranche” di contributi pubblici, di cui non conosciamo l’ammontare totale. Maggiori uscite, a carattere regolare: stipendi delle dipendenti e a seguire rimborsi spese per le socie. Terza maggiore uscita in ordine di importanza: iniziative sul territorio (cioè il marketing femminista). In coda le spese di gestione: bollette, cancelleria, affitti (questi ultimi spesso risibili o inesistenti grazie ai buoni uffici di qualche municipalità). Un bravo investigatore delle Fiamme Gialle probabilmente saprebbe scovare tra varie altre voci poco comprensibili le prebende e i trasferimenti impropri ad amiche o referenti nella politica, o nei media, o in altri settori-chiave (chissà, magari pure nella magistratura stessa).
Il problema è che in quel mondo né le Fiamme Gialle né i magistrati osano mettere il naso, probabilmente per timore dell’impopolarità e forse anche per fiancheggiamento o adesione ideologica. Peccato perché la sussistenza da anni di una “femministopoli” è a nostro parere piuttosto evidente e drena una quantità scandalosa di svariati milioni di euro pubblici per un’attività in gran parte inutile, quando non dannosa. Il numero esiguo di casi di vera violenza con vittime donne o uomini potrebbe essere tranquillamente gestito dallo Stato tramite consultori o sportelli dedicati, previa debita formazione. Invece con il denaro di tutti si mantengono veri e propri stipendifici, il che, in termini assistenziali potrebbe anche essere accettabile, se non fosse che il tutto comporta la sopravvivenza di centri di clientela politica e di propaganda ideologica divisiva e conflittuale, vere e proprie industrie della falsa accusa dedite all’inquinamento della giustizia e dell’opinione pubblica (oltre che dei malcapitati, uomini e donne, che finiscono nell’ingranaggio). Il tutto, ben inteso, al netto di quei due o tre centri antiviolenza che coraggiosamente fanno il proprio dovere in modo pulito, accettando ad esempio di assistere anche gli uomini.
Eppure, prima ancora di utilizzare la magistratura per interrompere questo fenomeno devastante degli equilibri sociali e delle finanze pubbliche, basterebbe stabilire criteri “europei” per la gestione della partita contro la violenza interpersonale. Basterebbe vietare gli affidamenti alle associazioni, consentendolo a entità con forme giuridiche più controllabili e soggette a tutte le normative di garanzia. Basterebbe, dal lato finanziario, che valesse per i centri antiviolenza ciò che vale nella progettazione europea: si fa un business plan (dove si dimostri la verifica dell’esistenza di un fabbisogno reale), si ricevono i soldi, dopo un tot di tempo si rendicontano le spese con pezze d’appoggio qualificate e ciò che non si è speso viene restituito. E se per caso gli obiettivi del progetto non vengono raggiunti, si viene esclusi da ulteriori futuri benefici. Un obiettivo ragionevole per ogni centro antiviolenza potrebbe essere l’uscita da uno stato di violenza di almeno 50 persone (uomini o donne) all’anno, da comprovarsi concretamente attraverso le autorità pubbliche, magistratura, forze di polizia, servizi sociali e altro. Con poche regole del genere, cesserebbe in un paio di mesi la doppia rapina, di risorse pubbliche e di pace sociale, realizzata già da troppo tempo dai centri antiviolenza. Così però non è. Anzi si è imboccata da tempo la strada di un radicamento e un potenziamento pericolosissimo di queste strutture privilegiate e sottratte da ogni controllo. Con gli esiti scandalosi di cui parleremo nell’articolo di lunedì.