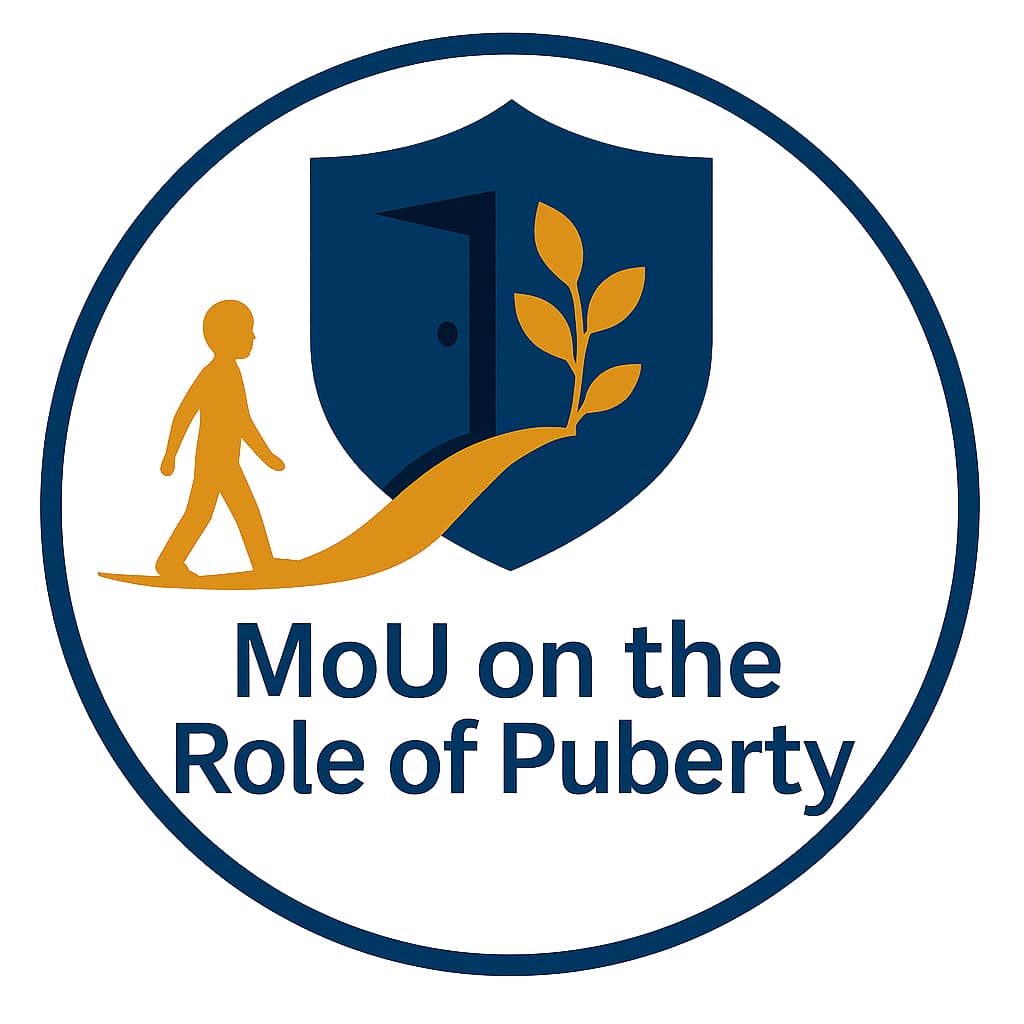Veniamo quindi alla seconda e ultima fonte, la review di Goldfarb e Lieberman del 2020. Gli studiosi hanno lavorato su un corpo iniziale di oltre ottomila studi, dei quali però, eliminati come da protocollo quelli privi dei requisiti di attendibilità o criteri di pertinenza, ne hanno valutati solo 80 per la review effettiva, di cui 39 effettuati negli USA, i restanti in altri paesi ma soprattutto in Canada e Australia (solo una dozzina hanno coinvolto alcuni paesi europei o paesi esterni all’“orbita occidentale”). Tra i risultati benèfici che sarebbero comprovati da questi studi sono anzitutto elencati quei cavalli di legno tinti di arcobaleno etc. già visti nel documento Unesco del 2023, sotto la prima sezione dei “risultati” a pag. 16, intitolata “Apprezzamento della diversità sessuale” (!). I risultati che ci interessa verificare vengono ovviamente dopo, a pag. 20, nella sezione “Prevenzione della violenza nelle relazioni tra i giovani”.
Tralasciando le parti che misurano un miglioramento della “consapevolezza” o delle “intenzioni” degli studenti dopo le lezioni, arriviamo alla sottosezione che misura l’effettiva violenza relazionale a seguito delle lezioni di educazione affettiva e sessuale. Questa sezione cita i 14 studi pertinenti a questo aspetto specifico (sugli 80 totali): di questi soltanto due sono review, che hanno un valore più “probante” nella gerarchia delle fonti, dato che mettono a confronto tra loro un certo numero di ricerche piuttosto che riguardare gli esiti di un singolo esperimento. La prima è una ricerca del 2017 che ha verificato, analizzando un totale di 23 studi, l’effetto delle lezioni di educazione sessuale-affettiva sulla conoscenza di quali comportamenti costituiscono violenza relazionale, sull’attitudine dei soggetti in merito, e sull’effettiva perpetrazione e vittimizzazione pre- e post-intervento, definita come: «aggressioni verbali, gelosia, tendenza a controllare il partner, aggressioni fisiche, coercizione sessuale» (pag. 13). Ritroviamo quindi il solito trucco già incontrato molte volte (ad es. qui) di allargare la definizione di “atti di violenza di genere” nel ventaglio tra un commento negativo sul taglio dei capelli, alla mera espressione di gelosia, fino allo stupro e all’aggressione fisica.

“Un’efficacia generica”.
Gli autori sottolineano poi che «i 23 studi valutati erano tutti a rischio medio-alto di bias, cioè di contaminazione dei risultati dovuta a elementi di soggettività e pregiudizi; di fatto nessuno degli studi valutati ha riportato alcun protocollo di ‘blinding’ (cecità) nella conduzione della ricerca né delle misurazioni. Ciò riflette la natura della ricerca basata su ambienti scolastici, in cui è impossibile creare condizioni di ‘cecità’ degli studenti e dei ricercatori». In altre parole, se uno studente, dopo aver fatto il ciclo di lezioni, decideva di considerarsi meno geloso o meno “tendente al controllo”, tale autopercezione soggettiva veniva registrata nei risultati finali come una effettiva riduzione della perpetrazione della violenza. Infine, solo una piccola porzione dei 23 studi totali era pertinente alla perpetrazione o vittimizzazione di violenza relazionale (definita come abbiamo segnalato). Ebbene, tenuti presenti tutti questi caveat, gli studiosi concludono che «l’analisi ha rivelato un effetto complessivo estremamente basso, statisticamente non significativo sulla riduzione della perpetrazione della violenza relazionale rispetto al campione di controllo»; che «l’analisi ha rivelato un effetto medio statisticamente non significativo sulla riduzione della vittimizzazione della violenza, rispetto al campione di controllo»; e che anche la misurazione di effetti nel follow-up, cioè dopo un certo lasso di tempo, «non arriva ai livelli di significatività statistica».
Perché questa ricerca viene citata nella review di Goldfarb e Lieberman tra i 14 studi (ricordiamolo, su oltre ottomila scartati) che dimostrerebbero l’efficacia dell’educazione sessuale-affettiva nel ridurre e prevenire la violenza di genere, se nelle conclusioni registra praticamente l’opposto? (Le altre 13 fonti citate non fanno eccezione, e ad un più attento scrutinio rivelano tutte problemi analoghi; per ragioni di spazio rimando ad una breve analisi di dettaglio di ciascuna, per chi volesse verificare o approfondire.) Anzitutto, grazie al solito trucco, già visto e rivisto mille volte, di definire “violenza di genere” in modo talmente ampio da considerare un atto di violenza anche un complimento negativo o l’espressione di un sentimento di gelosia. Poi, perché le review iniziano selezionando gli studi da valutare tra database enormi in automatico, per mezzo di parole-chiave: per cui se una ricerca misura l’effetto di un programma educativo sulla violenza effettivamente perpetrata e subìta, insieme ad altri parametri come la “consapevolezza” o l’“attitudine” del soggetto sulle “questioni di genere”, quella ricerca verrà inclusa nella review. E se la conclusione registra genericamente effetti positivi, allora sarà considerato tale risultato generico anche in sede di analisi di livello superiore, “perdendosi per strada” il fatto che l’effetto positivo era presente, o statisticamente significativo, solo per alcuni dei risultati elencati e misurati, ma non per tutti. Ma chiediamoci ancora: perché lo studio Unesco, che si basa su quello di Goldfarb e Lieberman, viene citato dai critici della Roccella come fonte scientifica attendibile a dimostrazione del fatto che le lezioni di educazione sessuale-affettiva ridurrebbero “i femminicidi”, o comunque produrrebbero un “netto miglioramento della situazione” a livello dell’intera società, se le ricerche di riferimento al più misurano gli effetti su limitati gruppi di studenti entro un certo periodo di tempo, e i “femminicidi” neanche li menzionano? Semplicemente perché come abbiamo visto Unesco afferma una generica efficacia nella riduzione della “violenza sessuale”, basando tale affermazione su quelle fonti secondarie, e con tutti i dettagli che si “perdono per strada” nel modo che abbiamo documentato. E pressoché nessuno va a verificare questi dettagli prima di citare la fonte Unesco. Mentre per molti è scontato dare credito alla premessa (non esplicitata, indimostrata e corrispondente alla fallace teoria della “piramide della violenza”) per cui aumentando la “consapevolezza” sulla “violenza di genere” in tutte le sue forme, a cominciare da quelle minime come il catcalling o dire a una ragazza che è più bella senza trucco, si otterrà un “cambiamento culturale” sensibile nei comportamenti di un’intera società, compresa la riduzione degli episodi-culmine, le punte dell’iceberg, i “femminicidi”.
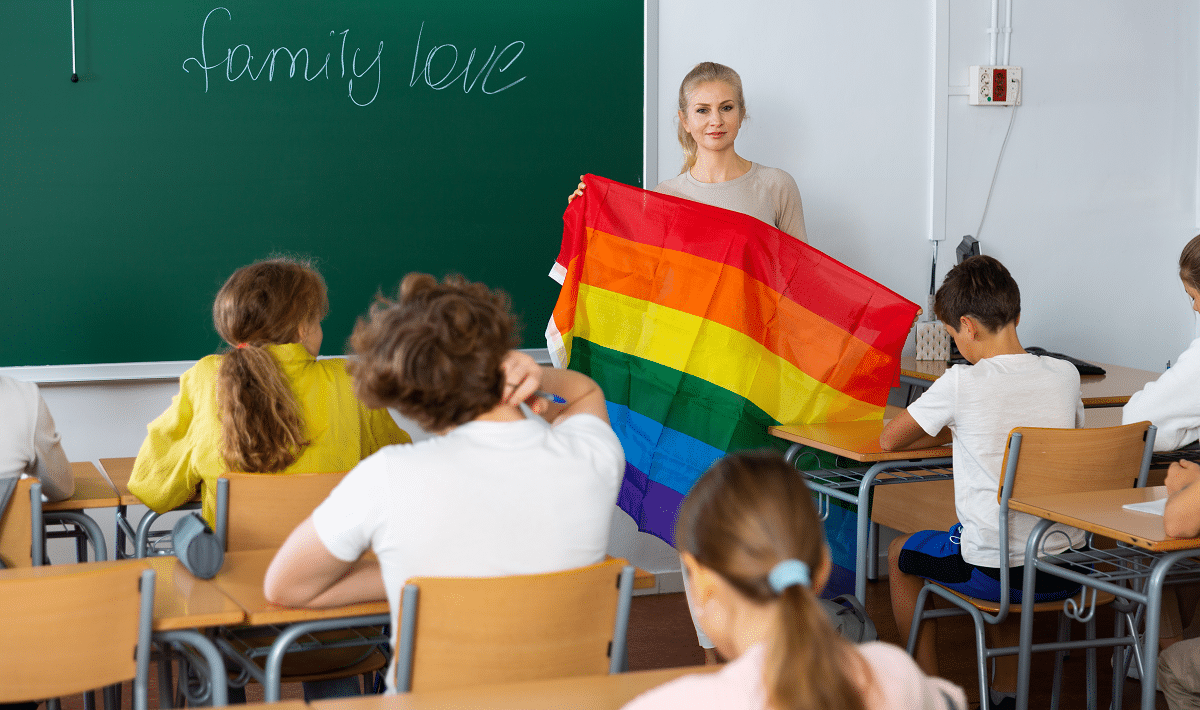
Nessuna correlazione.
Per misurare questo eventuale effetto, l’unico strumento che abbia almeno un parziale senso è confrontare i tassi di “femminicidi” nei paesi che la prevedono come obbligatoria rispetto a quelli dove è presente solo in maniera facoltativa e extra-curriculare. Secondo una indagine richiesta dalla Commissione Europea e pubblicata nel 2020 dall’Ufficio per le Pubblicazioni dell’UE, al novembre 2019 erano 19 gli Stati dell’area europea a prevedere un qualche tipo di educazione sessuale-affettiva obbligatoria nelle scuole, in alcuni casi fin dalla scuola primaria e da decenni. Utile sottolineare che la principale fonte del documento 2020 in questione è un documento del 2016, commissionato a sua volta dal “comitato FEMM” (nome che è tutto un programma!), cioè un gruppo del Parlamento Europeo dedicato ai diritti delle donne e all’uguaglianza di genere; e che gli autori di tale indagine, pur includendovi una valutazione sugli effetti benèfici risultanti dall’offerta di educazione sessuale-affettiva obbligatoria nelle scuole, non menzionano tra essi una riduzione della “violenza di genere” (men che meno del “femminicidio”). Secondo questi documenti sono otto gli Stati europei a non prevedere un’educazione sessuale-affettiva obbligatoria e curriculare nelle scuole: Bulgaria, Croazia, Ungheria, Italia, Lituania, Romania, Slovacchia e, curiosamente, la Spagna. Ebbene è facile verificare (ad es. qui e qui) che non c’è nessuna correlazione tra l’educazione affettiva-sessuale e i tassi di “femminicidi” in proporzione alla popolazione, che sono in certi casi anche molto più alti in paesi dove l’educazione sessuale-affettiva è obbligatoria rispetto a paesi dove non lo è (ad es. Spagna, Italia e Slovacchia registrano i dati più bassi).
Una notevole eccezione è la Svezia, dove il tasso è molto basso a livelli comparabili con quelli di Spagna, Italia e Slovacchia; in compenso i crimini violenti e gli omicidi verso le donne sono in aumento in Svezia negli ultimi anni, a differenza che in Italia dove oltre che molto pochi, sono pure in calo. In altre parole ci tocca riconoscere di dover proprio dar ragione alla Roccella su questo punto: l’educazione sessuale-affettiva nelle scuole non riduce né previene i “femminicidi”. In compenso, tra i 19 paesi europei che la prevedono in modo obbligatorio, molti includono in queste lezioni i bei cavalli di legno tinti di arcobaleno etc. che ormai riconosciamo da lontano, ad es. 16 paesi includono “orientamento sessuale/istanze LGBT” (!!), 10 “ruoli e norme di genere”, 8 “i diritti umani”. Sciò, via! Fuori i cavalli queer dalle scuole, e giù le mani dai bambini.