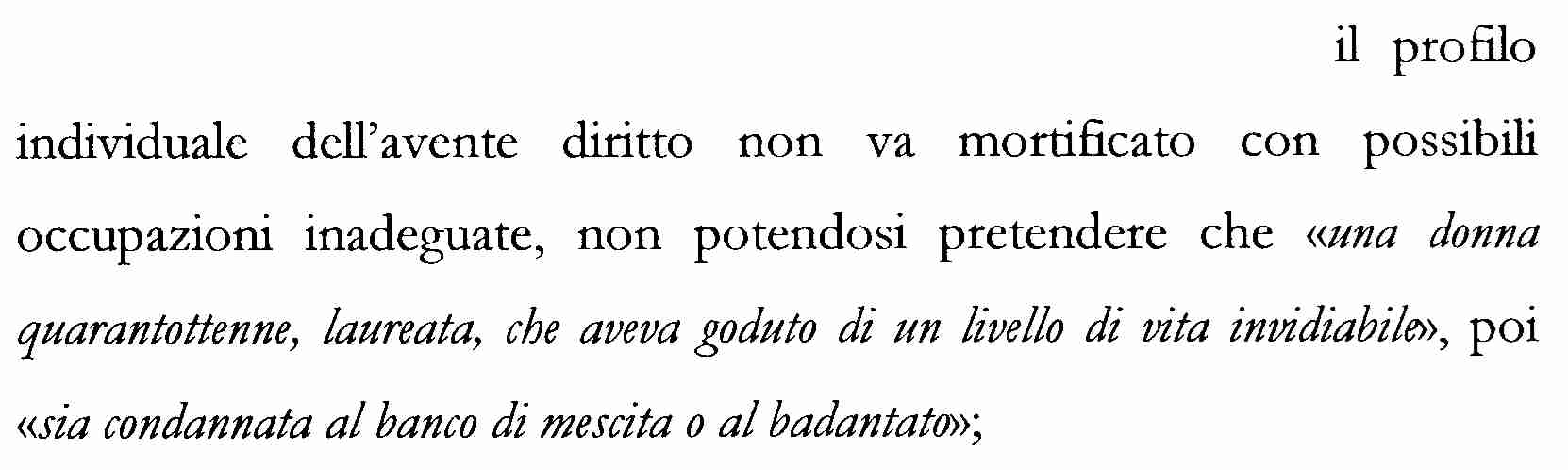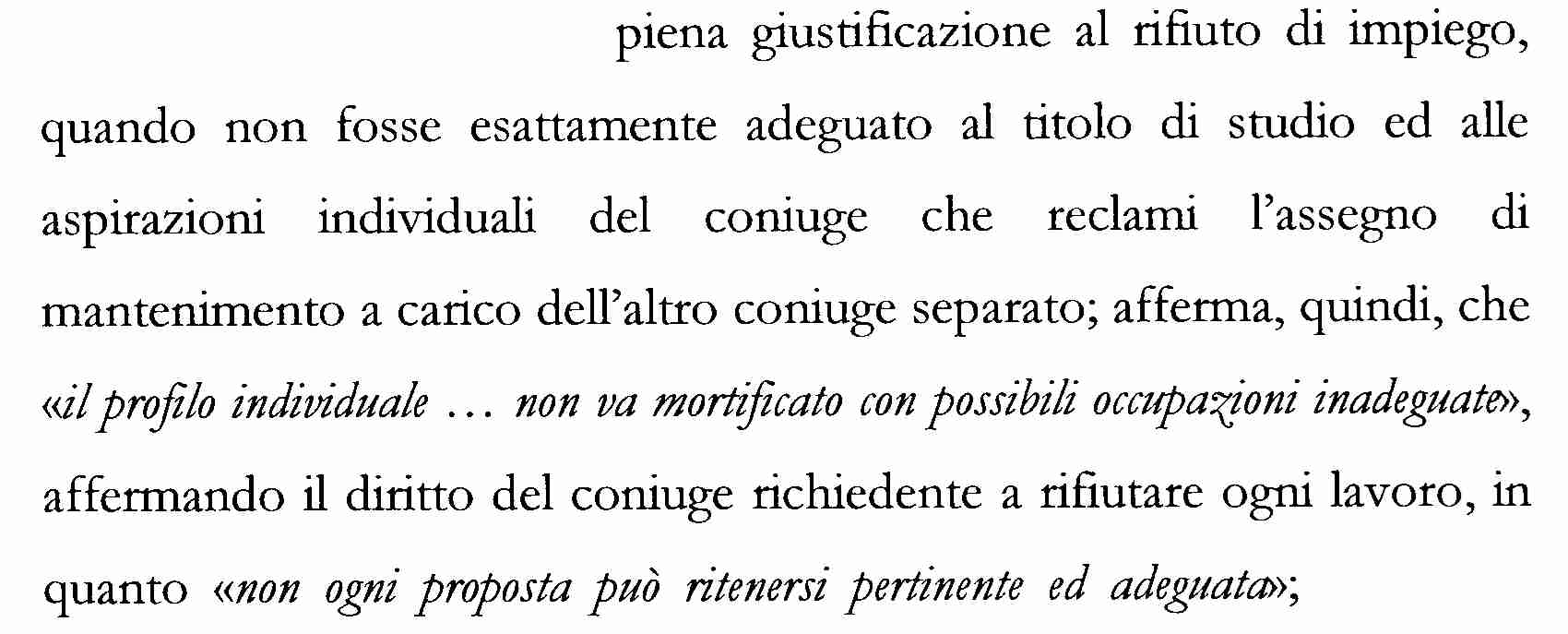Mi capita spesso di non concordare con i pronunciamenti della Corte di Cassazione, come per la posizione assunta nel caso della Procreazione Medicalmente Assistita, ma a volte devo riconoscere di trovarmi in linea con gli Ermellini. Sarà perché succede quando Piazza Cavour cassa le sentenze di Corte d’Appello? Forse, chissà… Probabilmente sento un bisogno ancestrale di contestare sempre qualcuno o qualcosa, mio padre giornalista deve avermi trasmesso l’indole del rompiscatole e non mi dispiace affatto quest’eredità. Con la sentenza 5932 – 2021 la Cassazione bacchetta la Corte d’Appello di Trieste per aver affermato che una donna laureata, abituata ad un alto tenore di vita, non può essere «condannata al banco di mescita o al badantato».
Che condanna infame sarebbe doversi abbassare addirittura a fare la barista, che diamine. La signora è laureata in lingue, quindi non può accettare niente di diverso da incarichi tanto remunerativi quanto autorevoli. Mi chiedo se in Corte d’Appello sappiano che: 1) essere laureati non è, purtroppo, garanzia di lauti guadagni ed incarichi prestigiosi. 2) Decine di migliaia di laureate e laureati, giovani e meno giovani, accettano lavori sottoqualificati rispetto ai titoli acquisiti. 3) Il fenomeno della fuga di cervelli non è un’invenzione giornalistica, le menti (e i curricola) più brillanti hanno poco spazio in Italia e vengono più facilmente valorizzati all’estero 4) Per rimanere nel loro campo, in Corte d’Appello sanno quanti laureati e laureate tentano il concorso in Magistratura senza riuscire a superarlo? Sanno che un laureato in giurisprudenza può non diventare mai avvocato perché non riesce a superare l’esame di Stato? 5) Sanno che un’insegnante può trascorrere una vita da precario/a e diventare di ruolo alla soglia dell’età pensionabile?
Pora stella, mi vengono gli occhi lucidi.
Sono problemi oggettivi che conoscono fin troppo bene tutte le famiglie italiane che hanno fatto sacrifici, a volte anche importanti, per far prendere ai figli il classico “pezzo di carta” ma poi, pur di trovare un’occupazione e non gravare più sulle spalle di mamma e papà, ragazze e ragazzi fanno i turni al call center e tanti saluti al bacio accademico. Però la signora non può sporcarsi le mani con niente di meno prestigioso di ciò che il titolo le consentirebbe. Come fa a sopravvivere senza altri 1.000 euro al mese, potendo contare solo sulle sue modeste entrate (la sentenza non specifica a quanto ammontino, ma riconosce che ci sono) e con “soli” 1.300 euro per i figli, più la casa, più il 50% delle spese straordinarie?
Pora stella, mi vengono gli occhi lucidi. L’ex marito vorrebbe mortificarne il profilo individuale proponendole di lavorare, pensa un po’. Anzi, trovandole più di un lavoro che però la signora ha tutto il diritto di rifiutare. Resta da capire se i giudici triestini si divertano a fare gli spiritosi o se veramente il tizio abbia proposto alla ex «ci sarebbe la signora del terzo piano che ha bisogno di una badante per il nonno: vitto, alloggio e 500 al mese».
La signora pretende un’occupazione non solo “esattamente adeguata” al titolo di studio, ma anche alle aspirazioni individuali. Ah però… Quindi, se anche l’ex marito le avesse trovato lavori da interprete, traduttrice o insegnante – in linea col diploma di laurea in lingue straniere – la signora avrebbe potuto continuare a rifiutarli in quanto non confacenti alle aspirazioni individuali. Che ci vuoi fare: quando una aspira, aspira. E se la signora aspira alla segreteria particolare del Consolato Generale italiano a Parigi, bisogna aspettare che si liberi proprio quel posto lì. Lei non ha fretta, può continuare ad aspirare con calma tanto nell’attesa paga Pantalone. Accantonando l’ironia, bisogna cogliere gli aspetti estremamente seri della vicenda: lo svilimento offensivo del lavoro manuale e la cronica asimmetria valutativa a seconda del soggetto di cui stabilire i diritti, che esita in una clamorosa discriminazione di genere. Dove il genere ad essere discriminato è quello maschile.
La Corte d’Appello triestina definisce una condanna lavorare in un bar o in un pub, usa le parole «condannata al banco di mescita» e se le parole hanno un senso, lavorare in quel modo equivale ad un’onta, una croce da portare con vergogna, una terribile umiliazione. Chissà cosa ne penseranno milioni di persone che si guadagnano onestamente e dignitosamente da vivere facendo il cameriere, l’operaio, il bidello, la colf, il muratore, il mozzo, il carrozziere, l’idraulico, il contadino, l’edicolante, il pescatore, il falegname, il facchino, l’operatore ecologico… Quanto alla discriminazione antimaschile, giova sottolineare che non esiste un solo precedente in cui un qualsiasi tribunale italiano abbia legittimato un padre separato a non versare un euro di mantenimento a moglie e figli poiché rifiutava ogni occupazione che non giudicasse consona sia al proprio profilo formativo che alle proprie aspirazioni personali.
Il doppio standard nei tribunali.
«Cocco, poche storie, rimboccati le maniche e vai a lavorare», è ciò che si legge tra le righe di migliaia di provvedimenti. Il giudice stabilisce l’allontanamento dalla ex casa coniugale e l’importo di un assegno mensile, ma non è suo compito accertarsi né dove vada a vivere il padre sfrattato (i puristi diranno che non è il termine esatto, lo so, ma rende l’idea), né come l’assegno venga coperto. Per un padre separato non esiste una sola sentenza, dicasi una, che stabilisca la «piena giustificazione al rifiuto di un impiego se non esattamente adeguato al titolo di studio e alle aspettative individuali di chi lo rifiuta». Se l’architetto va a fare il lavamacchine nessuno troverà da ridire, basta che paghi regolarmente. Qualora fosse un uomo a rifiutare sdegnosamente un lavoro non esattamente adeguato alle proprie aspettative, troverebbe – giustamente – l’intero sistema giudiziario pronto a redarguirlo. Quando a farlo è una donna, invece, trova qualcuno che si genuflette al servilismo d’ordinanza: assenso a prescindere, prima ancora di sapere quale sia la richiesta. È il patriarcato.