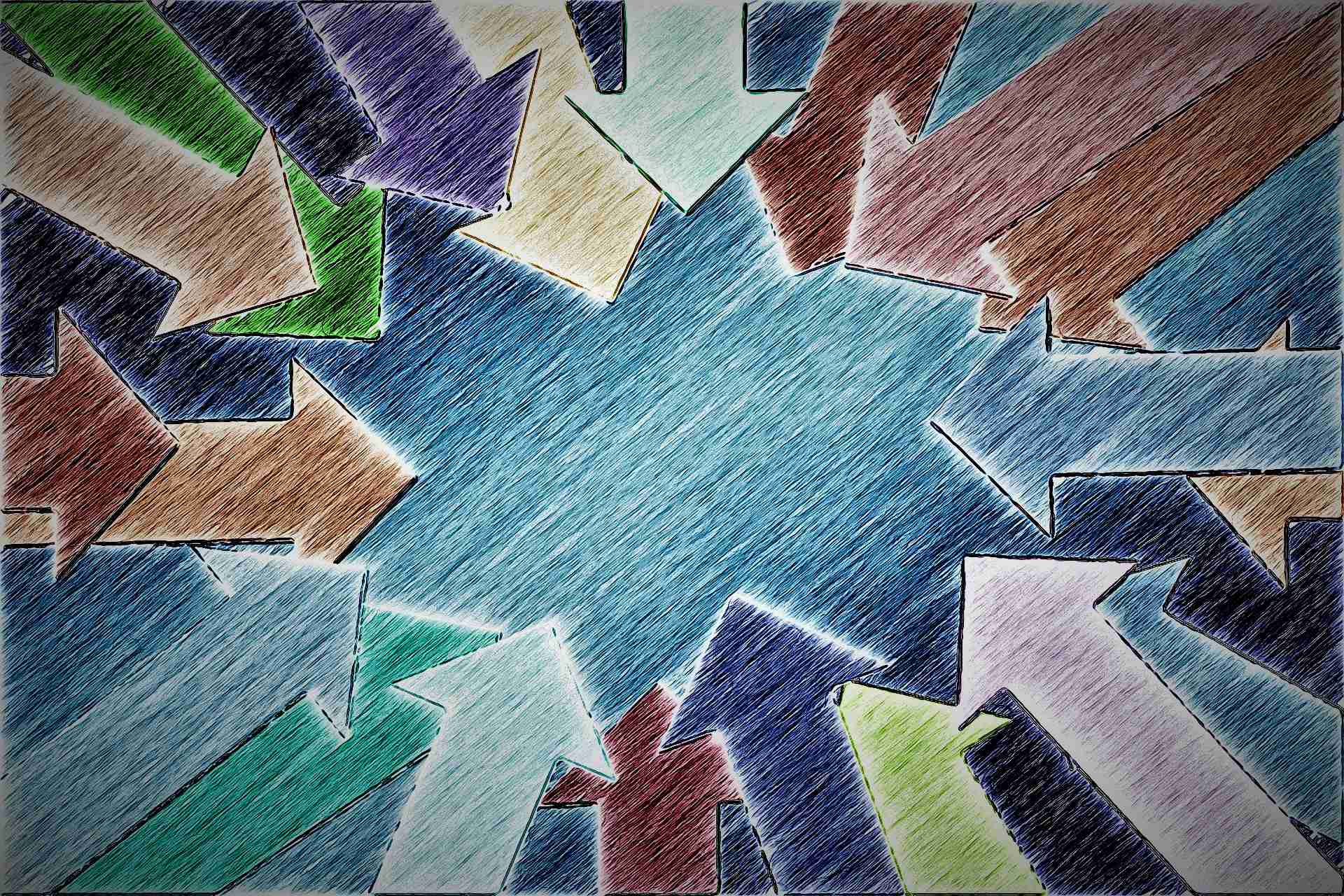. In uno studio del 2019, Giulia Giannotti (Università di Firenze), dopo una sintetica panoramica del rapporto intercorso nel tempo tra il femminismo e il diritto, tenta di dare una definizione, o meglio di indicare lo scopo e i campi di applicazione, di ciò che definisce “Giusfemminismo”. Per l’autrice, «la definizione del giusfemminismo quale teoria critica del diritto, la potremmo presentare come il ripensamento del diritto in un’ottica inclusiva di diverse soggettività, che porta allo smantellamento della presunta neutralità delle norme di legge, e più in generale del diritto. Questa definizione è perlopiù comprensiva delle diverse tesi sostenute dalle femministe dell’eguaglianza e della differenza, e ha il merito di evidenziare il forte nesso che intercorre tra femminismo, raggiungimento della libertà femminile, e il diritto in generale». Riprendendo le tesi della sociologa Carol Smart, secondo la Giannotti tre sono le fasi che caratterizzano il rapporto fra femminismo e diritto, riassumibili negli slogan: «il diritto è sessista, il diritto è maschile, il diritto è sessuato».
La prima fase sarebbe contraddistinta dalla non eguaglianza sul piano formale dei sessi, in funzione della quale le donne erano discriminate e impossibilitate per legge a svolgere certe professioni, e perciò confinate nella sfera privata. A cavallo fra il 1700 e il 1800, e fino alla metà del XIX secolo, le rivendicazioni del femminismo della prima ondata, di cui queste pagine si stanno occupando negli appuntamenti domenicali, avevano come obbiettivo il raggiungimento della piena parità giuridica in tutti i campi fra donne e uomini, e la dimostrazione che «l’inferiorizzazione delle donne non è un dato di natura ma una costruzione storica, sociale e culturale». La seconda fase è quella del femminismo della differenza. Il diritto viene criticato nella sua struttura, in quanto di per sé inadatto a ottenere la libertà femminile, che non può prescindere da una liberazione anche linguistica e sessuale. Dunque la norma giuridica è efficace se recepisce i valori morali e sociali già vigenti nella società, ma non li crea essa. Viene così rovesciata la visione giuspositivista che affida alla norma il compito di formare, forgiare, quei valori sociali che afferma e che finiranno per essere accettati/fatti propri dal corpo sociale.
Le donne assimilate a una minoranza che va aiutata.
«È in questo punto – scrive la Giannotti – che il diritto è diventato sì obiettivo e imparziale, ma questi due principi sono a loro volta maschili, costruiti dall’uomo e per l’uomo». Ne discende la necessità «di smantellare l’intero sistema giuridico. Questo è l’obiettivo delle femministe della differenza: creare un sistema giuridico basato sull’esistenza di una differenza sessuale (intesa come differenza naturale e originaria dei due sessi, senza il riconoscimento della quale l’eguaglianza sostanziale non sarebbe raggiungibile). Si tratta cioè di abbandonare quel soggetto maschile quale unico soggetto di riferimento del diritto e di trovare un diritto in grado di rappresentare i due generi». Nella terza fase del rapporto fra femminismo e diritto «le strategie sono meno rigide, considerano l’eguaglianza sostanziale e le azioni positive per ottenerla», come le quote rosa e le norme a tutela della maternità.
Tuttavia ciò pone un dilemma, evidenziato dalla giurista Martha Minow: «l’uso di azioni positive o meno comporta un paradosso. Da una parte, se le leggi sono solo “sex-blind”, cioè leggi di parità (che trattano in modo uguale situazioni differenti, e quindi potenzialmente creatrici di situazioni di ingiustizia sostanziale), la differenza rimane, e l’eguaglianza sostanziale non è garantita. D’altra parte invece, con la promulgazione di leggi cosiddette “sex-responsive”, cioè di azioni positive che operano un approccio differenziato per il raggiungimento di un’eguaglianza non solo formale ma anche sostanziale, allora si pone un problema: le donne sono assimilate a una minoranza che va aiutata, a una categoria sociale ‘problematica’ che necessita politiche speciali, e così intrinsecamente si conforta l’idea di un diritto maschilista, fondato su un paradigma di riferimento maschile. […] Quando si va a favorire una classe sociale invece di un’altra con politiche attive, non solo questa sarà considerata una classe più debole che necessita tutela, come abbiamo già detto, ma anche la classe opposta (gli uomini in questo caso) si sentirà ingiustamente svantaggiata».
Un diritto frammentato per tanti quanti sono gli individui.
Come uscire dall’empasse? Secondo la Giannotti, il soggetto di riferimento del diritto e delle norme da esso contenute, è l’Individuo. In un’ottica giusfemminista, quello che ci si deve chiedere è se questo Individuo, questo parametro di riferimento che assolve un’esigenza di isonomia (uguaglianza di tutti e tutte di fronte alla legge), sia veramente un soggetto neutro e imparziale, o se in realtà non sia prevalentemente un soggetto sessuato, e di sesso maschile. Quindi il nuovo obiettivo del femminismo sta proprio nello smascherare la presunta neutralità dell’individuo titolare di diritti e creare un nuovo parametro di riferimento, una “nuova normalità”, nella quale possano trovare spazio per l’affermazione dei propri diritti e libertà, sia uomini che donne in quanto tali. Per arrivare a questa trasformazione, che imporrebbe quindi una vera e propria “rivoluzione giuridica”, ovvero una nuova sottoscrizione del contratto sociale da entrambi i sessi, per l’assunzione di un Individuo, questa volta veramente universale.
La linea di pensiero della Giannotti si pongono alcuni problemi, a partire da una contraddizione fondamentale. Se è pensabile un individuo, questa volta veramente universale, allora il contratto sociale sottoscritto da entrambi i sessi, dovrà necessariamente prevedere norme e regole fondamentali uniche, valide per l’individuo universale, sia esso maschio o femmina. Siamo cioè nel campo della piena uguaglianza formale, del resto, per ammissione della stessa autrice, già raggiunto. Senonché si dice anche che che l’individuo di per sé non esiste. Anzi, ci si spinge così avanti da scrivere che «ogni componente della società è connotato dalle sue caratteristiche che lo contraddistinguono dagli altri». Non vale neanche, dunque, la bipartizione nei due grandi gruppi femmine/maschi, e ogni individuo è visto come un microcosmo incommensurabile. Se dunque non esistono né l’individuo astratto e nemmeno il maschio e la femmina come archetipi portatori di esigenze, caratteri psichici, bisogni diversi e nascenti dalla diversità dei corpi, ne dovrebbe derivare, per logica conseguenza, non un diritto che tenga conto della bipartizione fondamentale fra i sessi, ma un diritto frammentato per tanti quanti sono gli individui, con buona pace dell’individuo universale, della logica e della realtà concreta.
Finché anche i maschi non resteranno incinti…
Dunque sarebbe in errore anche il femminismo della differenza quando perora un sistema giuridico che tenga conto della differenza sessuale. Che però non si capisce come dovrebbe essere declinata, dal momento in cui le norme che tengono conto delle esigenze naturali delle donne, come la maternità, vengono rigettate in quanto rimarcherebbero una debolezza (ma perché, poi, debolezza e non semplicemente specificità di cui tener conto?) intrinseca. La soluzione viene indicata nella decostruzione dello standard maschile e con una diversa impostazione del diritto. Bene, ma quale impostazione del diritto, con cosa sostituire lo standard maschile, e con quali effetti pratici, non è dato capire, a causa della confusione e sovrapposizione di concetti. Non esiste l’individuo astratto ma esiste quello universale, senza che si specifichi la differenza. Non esistono il maschile e il femminile in sé, ma solo individui diversi, dunque necessariamente portatori di standard soggettivi e unici. L’eguaglianza formale è una trappola, ma lo è anche la diversificazione normativa.
Si insiste poi sulla necessità di raggiungere una parità sostanziale oltre quella formale, per raggiungere la quale si perorano azioni positive, dunque non un diritto che recepisca la realtà fattuale già vivente nel sociale ma che ne crei una esso, o almeno che spinga decisamente verso la direzione voluta, la parità sostanziale, che però, non casualmente, non è definito cosa voglia dire in concreto. Potrebbe voler dire che ogni campo dell’umano agire deve vedere donne e uomini in ugual numero, ma in tal caso il presupposto è che donne e uomini abbiano le stesse inclinazioni, predisposizioni, passioni, gli stessi interessi concreti, le stesse caratteristiche psichiche e fisiche. Bene, ma allora varrebbe come principio supremo quello dell’eguaglianza sul piano formale, e le azioni positive dovrebbero proporsi soltanto di colmare il gap, sempre e ovunque si manifesti, a vantaggio dell’uno o dell’altro sesso. Anche, dunque, in quelle attività dove c’è da rischiare, e non solo nei luoghi di potere e prestigio, veri o presunti che siano. Aspettiamo fiduciosi le prossime rivendicazioni in tal senso, finora non pervenute.
Ma in tal caso cosa ne sarebbe della affermata differenza sessuale, in forza della quale si rifiuta come un trappola l’eguaglianza formale, con ciò delineando la possibilità di percorsi normativi differenziati? Un tentativo di soluzione, secondo la Giannotti, lo leggiamo nell’affermazione, esemplificata nel caso della maternità, che una situazione normale dovrebbe essere quella in cui «la metà degli “individui lavoratori” intesi in senso giuridico, possono rimanere incinte». D’accordo, ma poi, in concreto? Finché anche i maschi non resteranno incinti (e magari con la PMA, le “famiglie” omogenitoriali e la tecnoscienza ci arriveremo anche), occorre o non occorre prevedere norme che tutelino la lavoratrice in questione, come del resto già esistono? Se sì, allora si ammette implicitamente la differenza, con quel che ne consegue.
Le donne sono più uguali.
Si possono usare tutti i sofismi che si vuole, come potrebbe essere ad esempio quello di considerare la donna, invece dell’uomo, come parametro di normalità. Ma cosa cambierebbe di fatto? Nulla: quelle norme differenziate rimarrebbero sempre a tutela delle donne, con ciò contrassegnandone la mai troppo deprecata (da una parte del femminismo) diversità. Che è irriducibile in quanto dovuta alla natura, ma che non significa affatto inferiorità o superiorità. Se, al contrario, si pensa che in nome dell’eguaglianza quelle norme non debbano esistere, allora dove sta il problema? In conclusione, il giusfemminismo, nel momento in cui intende tenere insieme, o mediare fra, istanze e principi inconciliabili, affoga in molte contraddizioni, dalle quali è impossibile uscire se non facendo proprio l’aforisma di Orwell ne La fattoria degli animali, che nel nostro caso suonerebbe: “donne e uomini sono uguali, ma le donne sono più uguali”.