Quando si parla di suffragio sarebbe doveroso distinguere e analizzare di quale tipo di suffragio si parla: attivo o passivo? Il suffragio attivo consiste nel diritto che hanno i cittadini di votare i rappresentanti o i candidati di loro scelta. Il suffragio passivo consiste nel diritto che hanno i cittadini di essere eletti come rappresentanti del popolo (in un parlamento, in un’assemblea, ecc.). La narrazione storica femminista riguarda quasi in esclusiva il primo e trascura molto spesso il secondo. Il motivo? Probabilmente perché il secondo è arrivato molto prima del primo. In Spagna il suffragio femminile passivo viene proclamato nella Costituzione del 1837 (oltre 10 anni prima dell’incontro di Seneca Falls). Da allora le donne possono essere elette ai Parlamenti. Spagna non era l’unica, abbiamo già visto nell’intervento precedente come all’epoca anche in Francia esistesse il suffragio femminile passivo. Per la Spagna, come per ogni paese occidentale, una parte del percorso storico è particolare, specifico, ma l’altra è comune e riferibile anche agli altri paesi. Un altro elemento comune da evidenziare è il fatto che le denominate “democrazie” dell’epoca, erano tutte, o quasi tutte, false democrazie, monarchie parlamentari con divieti a partecipare ai partiti non affini, brogli, manipolazione ed elezioni truccate. A lungo in Spagna si sono alternati al potere in modo pacifico e in connivenza due partiti: i conservatori e i liberali. Un terzo elemento comune riguarda l’opposizione di molti e di molte, anche delle femministe, al voto delle donne. È stato già accennato come, per la Spagna, la capostipite del femminismo spagnolo, Concepción Arenal (1820-1893), ne era contraria: «non vogliamo né partiti né voto» scrive nella sua opera La mujer del porvenir. Secondo lei, le donne «influiscono nel voto attraverso il fratello, lo sposo, il figlio, il padre e persino il nonno», e non c’era dunque la necessità per il suffragio femminile. L’influenza del suffragismo femminile, e del femminismo in genere, come in molti altri paesi, è stato anche per la Spagna perlopiù trascurabile.
Afferma la scrittrice Pardo Bazán (1851-1921): «Quando fondai La Biblioteca della donna, il mio obiettivo era quello di diffondere le opere del femminismo straniero in Spagna […]. Ho visto, mio malgrado, che a nessuno interessano queste importanti questioni qui, e alle donne ancora meno. […] Qui non ci sono suffragette, né docili né ribelli» (tratto dall’opera La grande menzogna del femminismo, p. 578). La prima ondata femminista in Spagna era predominantemente ultraconservatrice e cristiana. Afferma María de Echarri (1878-1955): «Il femminismo possibile e ragionevole in Spagna deve essere chiaramente cattolico». In occasione della morte della regina María Cristina (1929), Carmen Díaz de Rabaneda ha espresso la particolare visione che lei, e molte come lei, aveva del movimento femminista: «La donna spagnola non potrà mai dimenticare la sublime lezione di straordinario femminismo che quella egregia signora ci ha regalato con tutta la sua vita; straordinario femminismo che noi, educate nelle nostre famiglie con un grande senso ispirato alla tradizione e al cristianesimo, abbiamo saputo sentire e praticare; che consiste nel rispetto, (…) della parola più stimata, quella pronunciata dal capofamiglia. Questa illustre regina, che ha saputo mantenere un comportamento esemplare, perché la sua intelligenza era illuminata, seppe anche mettersi da parte in ogni occasione e cedere il primo posto agli uomini della sua prestigiosa famiglia, e noi, donne spagnole, abbiamo imparato da questa lezione e in questo modo siamo riuscite a vedere negli uomini un alto esempio di spiritualità, virilità. Pertanto, abbiamo visto nelle nostre case affidata a loro la missione di dire sempre l’ultima parola nelle questioni ardue, accompagnata sempre dal contributo del consiglio femminile, pieno di amore e disinteresse». Queste donne erano più preoccupate della difesa dell’obbligatorietà dell’insegnamento religioso che al voto, e promuovevano la creazione di istituti femminili con lo scopo di raggiungere la separazione dei sessi a scuola. In Spagna il femminismo cattolico (maggioritario) e il femminismo socialista (minoritario) erano in conflitto. Afferma nel 1922 la femminista socialista Margarita Nelken: «le femministe spagnole, in generale, hanno relegato le loro rivendicazioni in quanto tali dando priorità alle loro ideologie politiche, e questo ha notevolmente indebolito il movimento per il suffragio spagnolo».
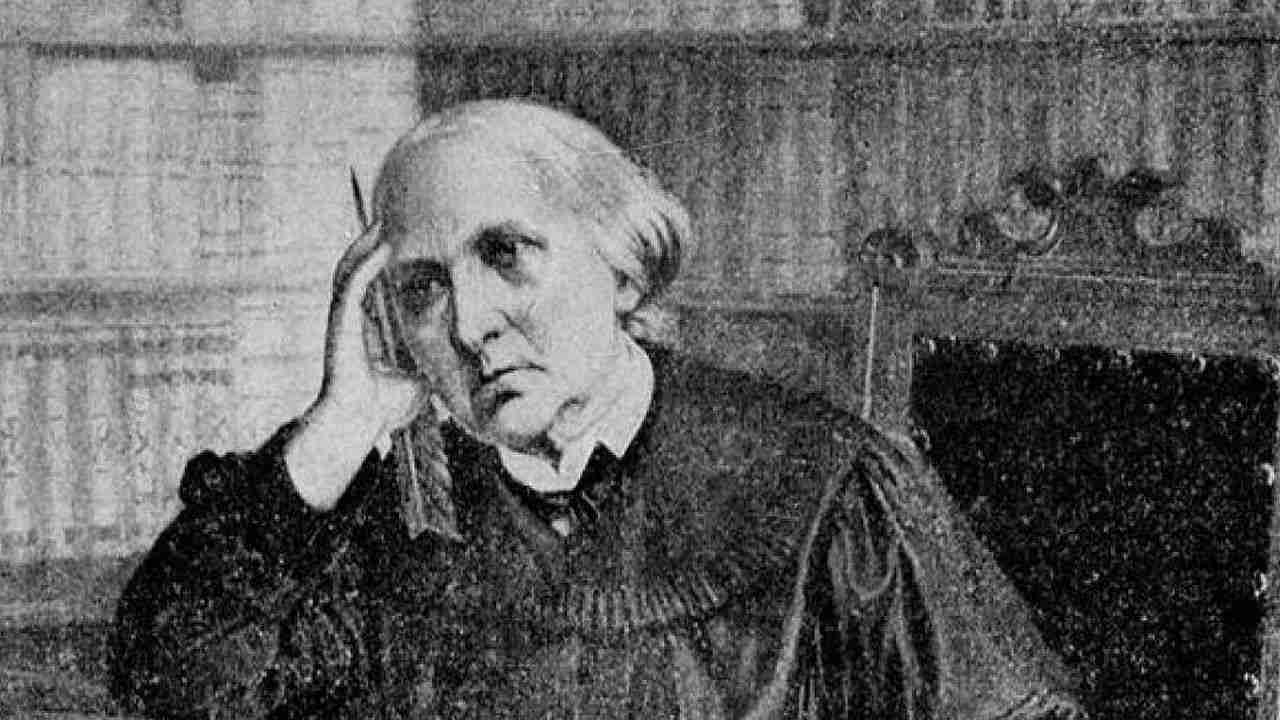
L’emancipazione fascista.
In Spagna i primi tentativi di riconoscere il suffragio femminile, senza successo, in maniera ristretta per alcune donne (di solito vedove, capifamiglia), provengono da uomini conservatori. Nel 1877 durante il dibattito sulla legge elettorale, sette deputati dell’ala più conservatrice presentarono un emendamento per riconoscere il voto delle “madri di famiglia, vedove o adulte, alle quali corrisponde la potestà genitoriale secondo la legge del 20 giugno 1862 e la riforma della procedura civile”; non ebbe successo. Nemmeno il progetto di riforma elettorale di Burgos Mazo del 1919, che riconosceva il diritto di suffragio attivo a “tutti gli spagnoli di entrambi i sessi di età superiore ai venticinque anni che godano pienamente dei loro diritti civili”. Nel 1924 il deputato conservatore Calvo Sotelo promuove la proposta di concedere il voto alle donne maggiorenni. È interessante menzionarlo perché il suo assassinio da parte di forze di sinistra nel 1936 fu il detonatore della tragica Guerra civile spagnola (1936-1939), con rilevanti ricadute anche sul resto d’Europa. Il suffragio femminile viene finalmente incluso durante una dittatura di destra, la Dittatura di Primo de Rivera (1923-1930), a livello municipale, nel Regio Decreto dello Statuto Municipale, dell’8 marzo 1924, e due anni dopo, nel settembre 1926, in occasione della celebrazione di un plebiscito nel terzo anniversario del colpo di stato di Primo de Rivera, è concesso il voto a tutti gli spagnoli maggiori di diciotto anni, senza distinzione di sesso. Nel 1927, nell’organico dell’Assemblea Nazionale Consultiva della Dittatura di Primo de Rivera c’erano quindici donne, anche se soltanto tredici ne presero pieno possesso.
In Spagna il suffragio universale femminile arriva nel 1931 con la seconda Repubblica, misura promossa dal Parlamento. Il voto in Parlamento per l’approvazione del suffragio femminile fu trasversale, ottenne più sostegno da destra e opposizione da sinistra. In Parlamento c’erano solo tre donne elette, due femministe di sinistra, Victoria Kent (Partido Radical Socialista) e Margarita Nelken (Partido Socialista), e una di destra, Clara Campoamor (Partido Radical). Le due prime votarono contro, Campoamor votò a favore. Se fosse dipeso soltanto dal voto delle donne e dalle femministe in Parlamento, le donne spagnole non avrebbero raggiunto il diritto di voto. Il suffragio femminile fu conquistato grazie al voto degli uomini in Parlamento. Dal percorso storico della Spagna si possono trarre diversi insegnamenti. Primo, malgrado gli attuali pregiudizi, dovuti all’ignoranza storica, molte conquiste delle donne sono state raggiunte grazie a movimenti politici di destra, non di sinistra. In altre parole, gli uomini patriarcali di destra promuovono il suffragio femminile. In Spagna, le prime cariche pubbliche furono donne di destra. Le proposte per l’approvazione del suffragio femminile provengono sempre da forze di destra, promosso a livello municipale durante una dittatura di destra e finalmente in Parlamento durante la Repubblica grazie alla destra. D’altra parte il dittatore Primo de Rivera non aveva fatto altro che copiare Mussolini. Il programma dei fasci di combattimento del giugno 1919 chiedeva il pieno diritto di voto per tutte le donne oltre i ventuno anni. Nel 1923 Mussolini introduce il voto amministrativo femminile che non ebbe applicazione perché il voto, qualche tempo dopo, fu eliminato per tutti. In linea di massima l’idea del fascismo era: o voto per tutti, se voto proprio deve esserci, o meglio ancora voto per nessuno. Se questo non è parità!

Contributo femminista? Zero.
Secondo, il suffragio è stato raggiunto senza il femminismo. Il contributo femminista è del tutto marginale. Terzo, si può dire che in alcuni casi il femminismo è stato un ostacolo (!), come è successo in Spagna. Alcuni illusi possono credere che la Spagna sia stata un’unica eccezione. No. Ecco alcuni esempi. All’incontro di Seneca Falls, nel 1948, delle dodici risoluzioni, l’unica a non passare all’unanimità fu quella del voto femminile. «In Francia, femministe e repubblicane si alleano nella lotta per la democrazia. A partire dal 1870, il femminismo francese si configura secondo l’indirizzo impressogli dal massone Léon Richer (1824-1911) e dalla libera pensatrice Marie Deraismes (1828-1894). I due capi del movimento non sono però favorevoli all’immediato conseguimento del diritto al voto delle donne, temendo un’avanzata delle forze cattoliche»; «Nel 1905, per ragioni tattiche, esse rinunciano alla rivendicazione del diritto delle donne al voto, per ottenere come prima cosa il suffragio maschile»; «Dopo il 1900 […] A differenza delle femministe angloamericane, le quali ponevano l’accento sulla parità dei diritti, le femministe borghesi italiane avevano poca fiducia che dalla forza del mercato o dal diritto al voto potesse nascere l’emancipazione»; «Nel 1870 nello Stato di Utah fu concesso il suffragio femminile, senza alcuna lotta da parte delle donne, promosso da gruppi di uomini anti-poligamia usciti dalla chiesa dei Mormoni, convinti che le donne dello Utah avrebbero votato contro la poligamia se fosse stata data loro un’opportunità. Purtroppo si resero conto di essersi sbagliati, anzi il voto femminile stava rischiando di mutare l’immagine di donne oppresse che il resto della nazione attribuiva alle donne dello Utah. La questione fu molto controversa anche all’interno della National Woman Suffrage Association, che in linea di principio erano d’accordo con il suffragio universale femminile, ma molte si opposero nel caso specifico dello Utah, perché ciò avrebbe rafforzato la chiesa dei Mormoni. Il suffragio fu revocato nel 1887 e reintrodotto definitivamente nel 1895» (citazioni tratte da diverse fonti, tratto dall’opera La grande menzogna del femminismo, a pp. 53, 578).
Molte femministe di quell’epoca si opposero al voto delle donne perché non ritenevano le donne ancora pronte, ritenevano la maggior parte di loro troppo conservatrice, cioè la maggior parte delle donne non era, ai loro occhi, abbastanza femminista. La storia della Spagna ci offre un ultimo insegnamento. Storicamente è corretto affermare che in Spagna le donne votano malgrado il femminismo. Eppure in Spagna, come ovunque nel mondo, vale la massima “le donne votano grazie al femminismo”, tutti ne sono convinti, e questa è la narrazione dominante nelle scuole e nelle istituzioni. Oggi ci sono targhe e strade, parchi, centri culturali che portano il nome di Victoria Kent e Margarita Nelken, a memoria del loro contributo femminista. Per assurdo, in Spagna a commemorazione della conquista del suffragio femminile del 1931, non si commemora mai il nome di alcun deputato uomo che votò a favore e permise quindi il diritto di voto alle donne. La narrazione storica femminista ha capovolto la verità storica, questo succede in Spagna e ovunque nel mondo. In conclusione, l’affermazione “le donne possono votare grazie al femminismo” è scorretta, le donne potevano votare prima dell’esistenza del femminismo (1), quando alcune donne potevano votare a molti uomini veniva negato lo stesso diritto, quindi la contrapposizione Patriarcato (uomini)/donne è falsa (2), e infine molte femministe si sono opposte al voto (3), come è successo ad esempio in Spagna. Restano da vedere, quindi, le lotte epiche delle suffragette negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Ma anche in questo caso, la storia è proprio così come ci viene raccontata? La mia tesi, che cercherò di approfondire nel prossimo intervento, è che il movimento suffragista abbia ostacolato e ritardato il raggiungimento del suffragio femminile.

