La foto di copertina di questo articolo raffigura una strada di Kolkata, India. Immaginate di trovarvi immersi esattamente al centro di quella fiumana di persone ed auto e a un certo punto di sentire il bisogno di esprimere una vostra idea, opinione, sensazione, positiva o negativa che sia. La proferite e nessuno lo nota. La dite ad alta voce e attirate al massimo l’attenzione di un paio di passanti. La urlate forte e a girarsi verso di voi sono tre-quattro persone, giusto una frazione di un secondo. Può capitare che qualcuno di loro vi si rivolga, vi risponda o commenti ciò che avete urlato, per poi reimmettersi immediatamente nel flusso della folla e sparire. Ripetete l’esperimento un po’ di volte e verificherete che l’effetto è sempre lo stesso. Cosa ne concludereste? Se siete persone razionali, capireste che lì, in quel contesto, è perfettamente inutile esprimere le proprie idee, opinioni o sensazioni, positive o negative che siano, a voce normale come ad alta voce. Nulla di ciò che pronunciate, in quel contesto, contribuisce a cambiare la realtà. Al massimo è uno sfogo per voi, che però, rimanendo ignorato e inascoltato, vi lascia più frustrati di prima. In conclusione, considerato il tutto e sempre che siate razionali: smettereste di farlo.
La condizione appena descritta è in buona misura corrispondente a quella che quotidianamente vive chi, una strabordante maggioranza di persone, affida a internet e ai social network buona parte della propria esistenza. Con alcune differenze cruciali, però, rispetto all’esempio della strada di Kolkata. Anzitutto su internet non si è circondati da persone in carne ed ossa. Dal vero hai comunque l’opportunità di un contatto d’occhi con chi poi ti snobba, volendo puoi provare a trattenerlo, la percezione della presenza fisica qualifica la circostanza in modo assai più significativo che su un social, dove la presenza è temporanea per sua stessa natura e l’essenza dei presenti è impalpabile e sfuggente. Quando si strilla la propria opinione su internet, si è circondati da bit cui il sistema dà per convenzione un nome e un cognome, ma che sono in grado di scomparire nel picosecondo che serve per cliccare un pulsante del mouse. E non è solo questo: l’immersione fisica in una folla ha l’inevitabile effetto psicologico di farci sentire piccoli, di sminuirci e ridimensionare la nostra autopercezione. Su internet, invece, il meccanismo scrittura-pubblicazione conferisce solennità al processo di espressione individuale: pesano su di esso il principio scripta manent, il senso di autorevolezza intrinseco alla manifestazione alfabetizzata scritta, quel sapore di ufficialità che la parola pubblicamente stampata ancora mantiene, più una serie di altri complessi meccanismi psicologici che, messi insieme, inducono l’opinionista internettiano a pensare non di essere un bit-nulla mescolato in un calderone di bit-niente, come in realtà è, bensì un’autorità che si esprime ex cathedra, con la missione (e la capacità effettiva) di avere in mano la soluzione ai problemi del mondo.
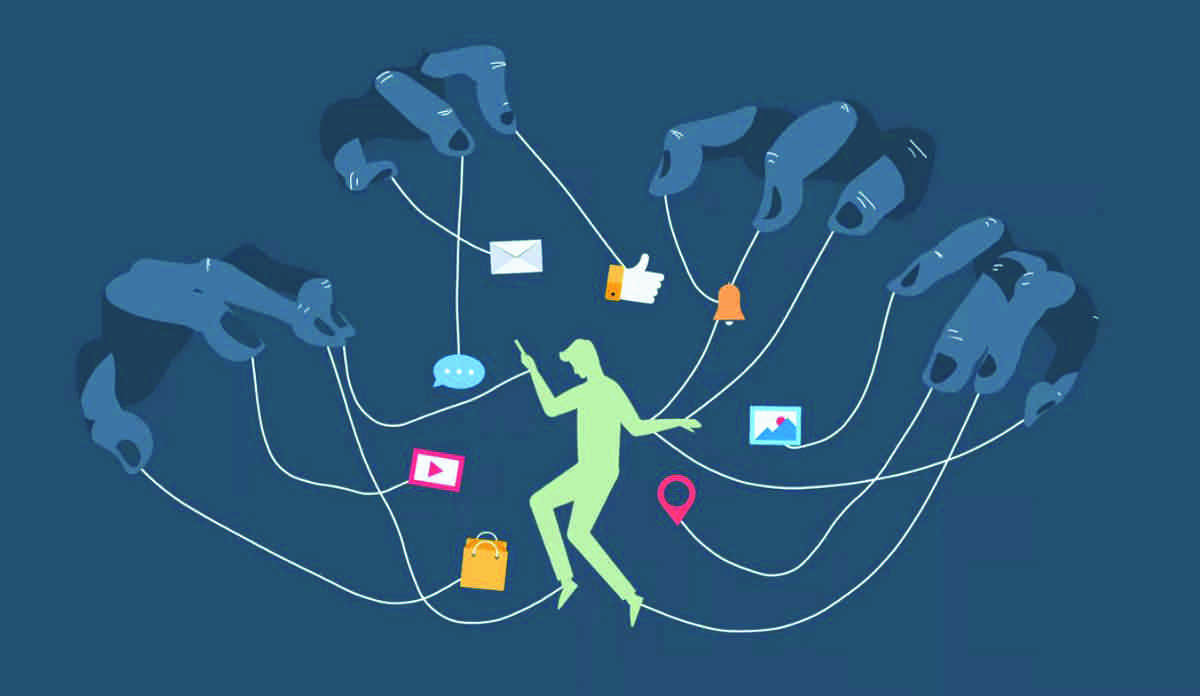
Cavie nel labirinto.
Eppure no, amici che vi affannate a pubblicare contenuti, frasi sferzanti, sentenze illuminanti, sfoghi accorati, trattati di sociologia o politologia, psicologia o letteratura, antropologia o medicina e arte: nulla di ciò che scrivete sulla sabbia dei social ha in sé i requisiti per cambiare anche solo un micron della realtà che ci circonda. Quand’anche raccogliesse centinaia, migliaia o centinaia di migliaia di “like” o condivisioni, il tempo di vita delle idee che esibite sul web si conta in secondi, quelli che servono ai miliardi di altri messaggi che intanto vengono pubblicati per spazzare via ciò che avete espresso, che sia qualcosa di brillante e illuminante o una castroneria colossale. Per non parlare di tutti coloro che spendono letteralmente ore a dibattere sui social, con ira e risentimento crescenti verso l’interlocutore, fino al naturale esito dello scambio d’insulti (talora pure con code giudiziarie). C’è chi di fatto vive, ossia trae un significato vitale profondo, da questa attività polemica, come se “vincere” la contesa con chi la pensa diversamente portasse a un cambio di regime del governo del mondo o contribuisse a salvare vite o a eliminare la povertà. La rete è piena di dibattiti infuocati su qualsivoglia argomento, ingoiati poi in pochi minuti dal buco nero dell’oblio internettiano. Al termine della contesa o dopo aver espresso in un brillante post la propria illuminante opinione, ciò che resta, anzitutto per l’autore, è un frustrante senso di desolazione. Chi è di sesso maschile lo sa: è la stessa sensazione che segue alla masturbazione. E di questo si tratta: una forma virtuale di masturbazione.
L’effetto è esattamente lo stesso: non c’è momento in cui un uomo sia più vulnerabile che dopo la masturbazione. La comunicazione internettiana e social ha lo stesso effetto, anzi la stessa funzione: spompare, scaricare, neutralizzare idee e pulsioni, buone o inutili che siano. Al di sotto di una parvenza di senso nasconde un meccanismo disarmante che genera una forma di dipendenza, secondo il pattern tipico di talune droghe ipnotiche. Partecipare attivamente e costantemente alla “vita social” significa immergersi in un nulla avvolgente, dove si è invitati a scalciare e agitarsi, nell’illusione di poterne uscire, salvo rimanerne sempre più impotentemente invischiati. Solo con un atto di ribellione e coraggio se ne può uscire e guardare il tutto da fuori, per accorgersi che i confini di quel nulla sono disegnati apposta entro linee di demarcazione che non possono essere messe in discussione dall’interno. Ad esempio, per i temi di nostro interesse, si illude chi pensa di poter “fare opinione” contro il dilagare della tossicità femminista o queer utilizzando internet o i social come strumento. Si tratta in realtà di trappole progettate appositamente da un sistema di cui entità come il femminismo e il queer sono parte integrante, si tratta di una cassa di risonanza dove dissenzienti e dissidenti vengono attirati e messi in condizione di non nuocere: lì possono urlare, riempirsi le orecchie dell’eco delle proprie voci, illudersi di essere determinanti nella lotta contro un “nemico” che nel frattempo li osserva, divertito, come uno scienziato pazzo osserva la cavia nel labirinto.
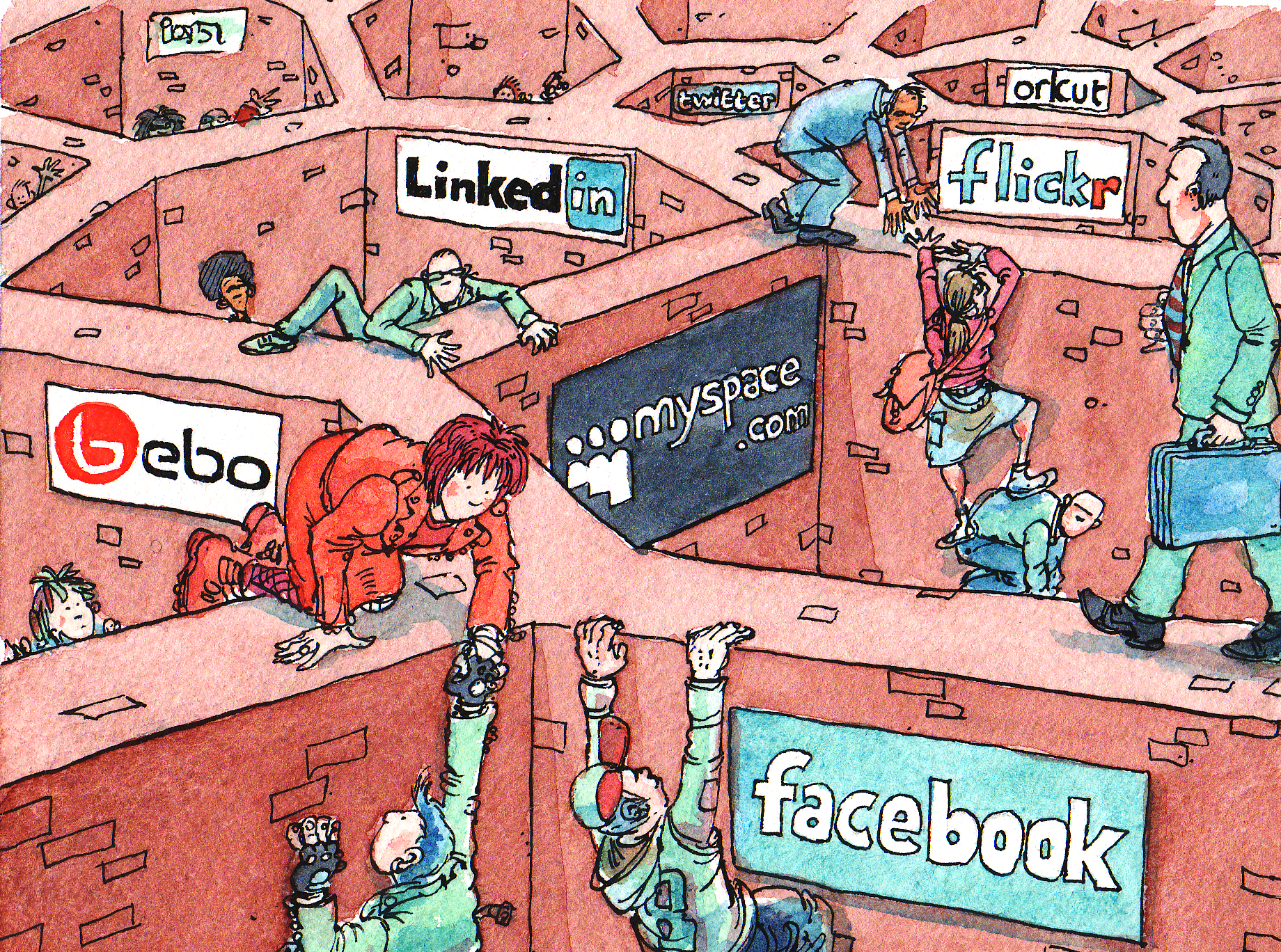
Quanti di voi?
Non c’è nulla, cari amici internettiani, che noi tutti possiamo scrivere, affermare o pontificare da queste pagine, e ancor meno dalle pagine dei social, che possa davvero cambiare la situazione. Non è nella natura delle cose che una lotta “comoda” possa portare a reali mutamenti. Fare i guerrieri contro il femminismo e il queer (o contro qualunque altra bruttura contemporanea) stando seduti su una poltrona, davanti a un monitor, con possibilità di pieno anonimato e di scappare dalle responsabilità con un click, non risolverà nulla. Confermerà anzi lo status quo, lo consoliderà sempre di più. La lotta, quella davvero efficace, è sempre scomoda, disagevole e sovvertitrice dell’ordine delle cose. Volete un esempio? Lo avrete a breve. Prima però fermatevi un attimo a pensare con concentrazione e profondità alle giornate che vivete e al tempo che dedicate alla vostra presenza online. Pensatevi in questo come un tossicodipendente old-style, di quelli barcollanti e alla costante ricerca di eroina da iniettarsi in vena, come si vedevano in giro negli anni ’80. Fatto? Ora pensatevi al di fuori di tutto questo. Niente più account social, autodisciplina nell’uso della messaggistica (solo per una cerchia ristretta e comunque dare la preferenza a telefonate dirette), email da usare solo per lavoro o affari ufficiali. Se conducete quest’astrazione in modo corretto vi renderete conto di due cose: niente di ciò che fate su internet è davvero indispensabile per la vostra vita. Chiudere il vostro profilo Facebook, al di là di un minimo disagio psicologico iniziale, non peggiorerà la vostra esistenza. Seconda consapevolezza: ci guadagnerete clamorosamente in termini di tempo, capacità di concentrazione, voglia di fare, di conoscere e di vivere. E di guardare il mondo attorno, mentre tutti gli altri guardano i loro display.
Sì ma, che fine fa, in questa condizione, la lotta contro il femminismo e il queer? Come si fa a contrastare l’operazione atta a distruggere deliberatamente la figura maschile nella percezione comune, se non si può più mettere un commento velenoso sotto un post di Freeda o della Murgia? Si fa. Si fa eccome. Ci si raccolga in associazioni, ma non di quelle dove il presidente si bea dell’essere il “boss” e gli altri stanno lì per piagnucolare e pietire attenzione per sé e per la propria storia personale. Si facciano associazioni con una missione chiara e un impianto ideale d’acciaio: mostrare al mondo che la maschilità è tutt’altro che tossica. Si aprano le porte a tutti, ma le attività siano riservate agli uomini, e siano attività reali, pratiche, concrete (e gratuite e apolitiche): accompagnare i disabili agli esami medici, portare da mangiare ai poveri, vigilare gli attraversamenti presso le scuole, portare la spesa a casa agli anziani, fare vigilanza pacifica nei quartieri, aiutare bambini e ragazzi a fare i compiti e a studiare, scortare donne e ragazze che debbano rincasare in condizioni di rischio, organizzare gruppi di lettura o di sviluppo culturale. Per queste ed altre necessità simili, si dovrebbe poter chiamare l’associazione “degli uomini”, che ti manda appunto uomini pronti a dimostrare nei fatti che la tossicità di cui si parla sui social e sui media è una banale menzogna, essa stessa tossica. Dieci associazioni così nelle dieci più importanti città italiane e nel giro di poco gli incubi distopici del femminismo e del queer svanirebbero in una nuvola sulfurea, ottenendo nel concreto e rapidamente ciò che una pioggia di post, tweet, commenti, like, video, reel, meme non potrà mai ottenere. La domanda però, a questo punto, sarebbe: quanti di voi, amici internettiani, sarebbero disposti a rinunciare all’illusoria cattedra bit-papale da cui comodamente pontificare, per scendere davvero in campo al servizio della difesa e della riaffermazione della dignità maschile?

