Una delle attività che potrebbero essere più divertenti e intellettualmente stimolanti, se non ci fossero di mezzo delle persone morte, è mandare totalmente in tilt una femminista dibattendo con lei sugli eventi omicidiari. Cosa piuttosto semplice, in verità, trattandosi di un tema su cui gli interessi di genere hanno innestato una quantità enorme di forzature che finiscono inevitabilmente per contraddirsi. L’obiettivo delle forzature è, naturalmente, quella di far apparire il genere femminile come vittima preponderante, oggetto di una persecuzione mortale messa in atto dal genere maschile, e per raggiungerlo si creano giri concettuali e di parole formidabili, non di rado mettendo sotto tortura numeri e statistiche. Non è difficile sbarrare la strada a quel tipo di “ragionamenti”, basta avere le idee chiare sul criterio usato, sulle categorie in gioco, e sul motivo della loro esistenza. Proviamo a mettere ordine, senza però tirare in ballo il solito “femminicidio”: questo sito pullula di articoli che smentiscono la fondatezza di un fenomeno che ancora, nonostante le richieste formali alle istituzioni, non ha una definizione unica, riconosciuta e non controversa, con ciò riducendo il termine a ciò che in realtà è, ovvero uno strumento di marketing e di clickbait.
Ci limiteremo allora ai percorsi propagandistici sul tema omicidiario che non si infognano nel controverso e facilmente smontabile “femminicidio”, ma fanno catenaccio su un concetto-chiave che spesso è letale nelle discussioni: sono di più le donne uccise da uomini che gli uomini uccisi da donne. Perché è un concetto letale, capace di tappare la bocca anche al più preparato degli antifemministi? Semplice: perché è vero. Assolutamente vero, è una verità inconfutabile contenuta nei numeri, gli stessi da cui chi pronuncia quella formula trae la credibilità della propria asserzione. Non solo: è letale perché nasconde in sé due trappole efficacissime, una emotiva e una puramente logica. Quella emotiva fa leva, come ogni cosa sostenuta dal femminismo, sul senso di colpa maschile. Nell’ascoltare quella frase è pressoché impossibile, se si è uomini, non sentirsi vagamente responsabili per la brutalità del proprio genere, in confronto a quella, molto inferiore, femminile. Usualmente la prima risposta a cotanta verità è un balbettio intimidito, e a quel punto la femminista è già in trionfo. Dopo l’esitazione si può dire ciò che si vuole, ma si è ormai sconfitti, avendo esibito un segno del proprio macerante senso di colpa. Che però non ha motivo di esistere. O meglio, ne ha talmente tanti che non vale nemmeno la pena provarlo: gli uomini uccidono (chiunque) più delle donne, da sempre, purtroppo. Sarà la prestanza fisica, sarà il testosterone, fatto sta che è così. Posto che non sempre lo fanno per cattiveria, ma magari per difendere la fattoria, la grotta, la famiglia, il proprio paese, eccetera. E nel farlo, sono rimasti e restano uccisi a milioni. Dunque senso di colpa… anche no.
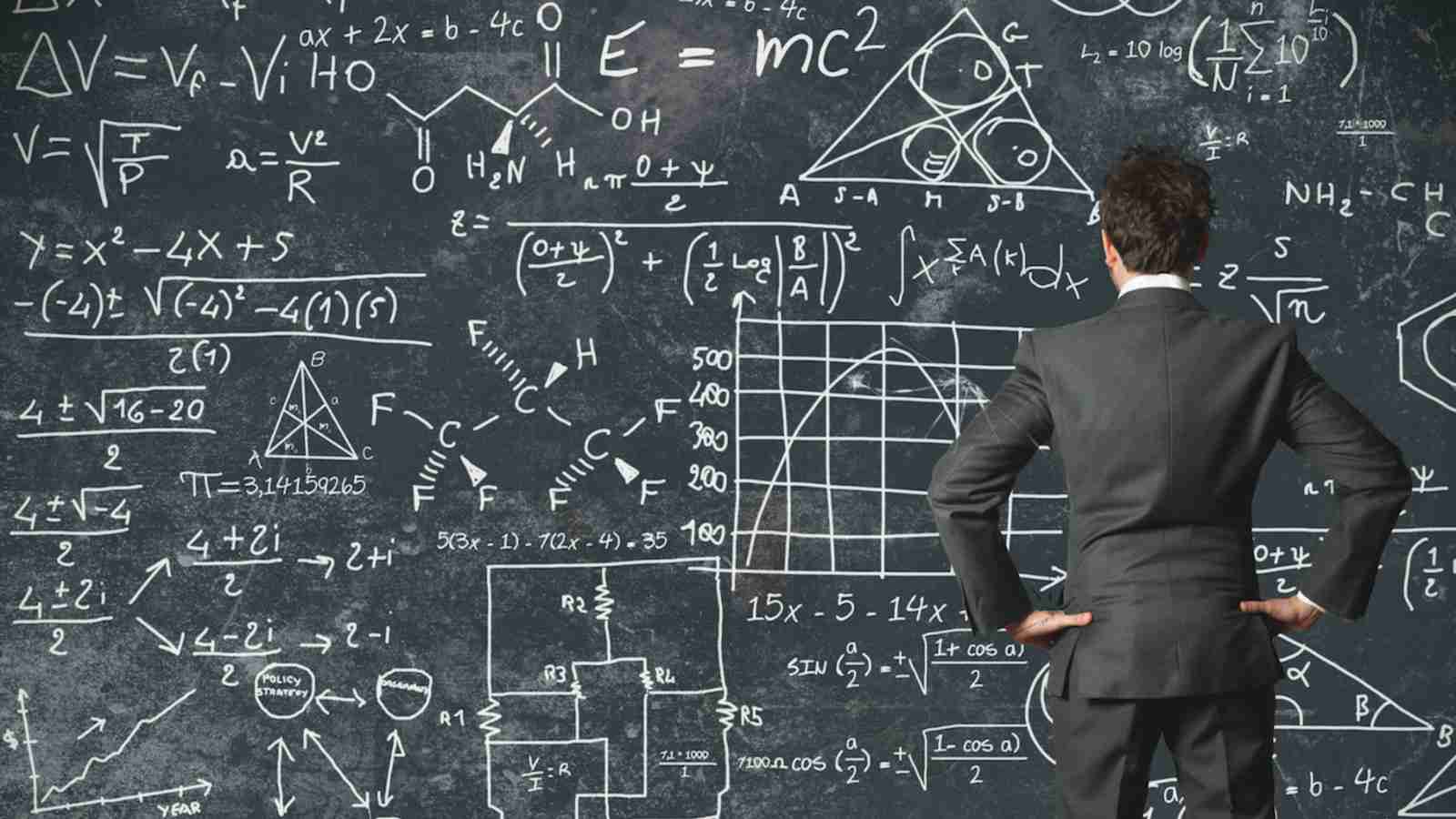
Carnefici odiatori da una parte, vittime martiri dall’altra.
Detto questo, va analizzata ora con profondità la trappola logica insita in quella formula. Il meccanismo è incardinato sul criterio del “chi uccide chi”. Lì è il cuore della questione. Provate a chiedere all’interlocutrice da dove prenda il dato che asserisce, e vi citerà qualche istituto di statistica a caso, ISTAT in testa. A quel punto fate lo sguardo stralunato e chiedetele: «ma perché l’ISTAT misura soltanto il dato di queste due categorie, uomini che uccidono donne, e non di altre? Perché non anche quanti eterosessuali hanno ucciso omosessuali e trans, e viceversa? O quanti autoctoni hanno ucciso immigrati, e viceversa? Quanti normodotati hanno ucciso disabili, e viceversa? Quanti settentrionali hanno ucciso meridionali, e viceversa?». Più allungherete la lista più vedrete la femminista impallidire. Già, perché la domanda è legittima: ci deve essere un motivo se, tra le tante possibili coppie di categorie da mettere in relazione in un contesto omicidiario, alcune magari particolarmente critiche, se ne sceglie soltanto una. Ed è proprio in quel motivo che sta il pulsante di disinnesco della frase che così tanto potere ha di ammutolire le persone di buon senso durante un dibattito con una femminista furbacchiona. Spiegarlo non è semplice e dipende anche da come si decide di gestire la controparte.
Si può decidere di attendere che azzardi una risposta, che sarà per forza improntata a una forma di suprematismo, qualcosa del tipo: l’omicidio di una donna per mano maschile “è più grave” di ogni altro. Al che diventa facile inchiodarla sulla croce del sessismo più bieco e infondato. Oppure si appiglierà disperatamente a numeri inesistenti, del tipo: gli omicidi di donne per mano maschile sono “di più” di ogni altra tipologia. Al che diventa elementare inchiodarla sulla croce dell’ignoranza: se i dati delle altre casistiche non ci sono, come fa a dire che sono “di più”? Altri tentativi di fuga la femminista già così non ne ha. Ma si può ipotizzare, invece di attendere una sua risposta, di proseguire noi il ragionamento, spiegandole l’esatto motivo per cui il “chi uccide chi” è il criterio guida delle statistiche e la base della sua frasetta. E il motivo è che quel criterio è l’unico modo per suggerire che ci sia una categoria di persone, nella fattispecie gli uomini, che uccide un’altra categoria, le donne, spinta da motivi di odio di genere. Cioè è il criterio utile per elaborare statistiche ideologiche, costruite per confermare un’idea di partenza, invece che elaborarne una dopo aver raccolto i dati. L’obiettivo è rafforzare e diffondere il dogma per cui c’è un genere che perseguita l’altro, sopprimendolo in modo istintivo e sistematico. Carnefici odiatori da una parte, vittime martiri dall’altra.
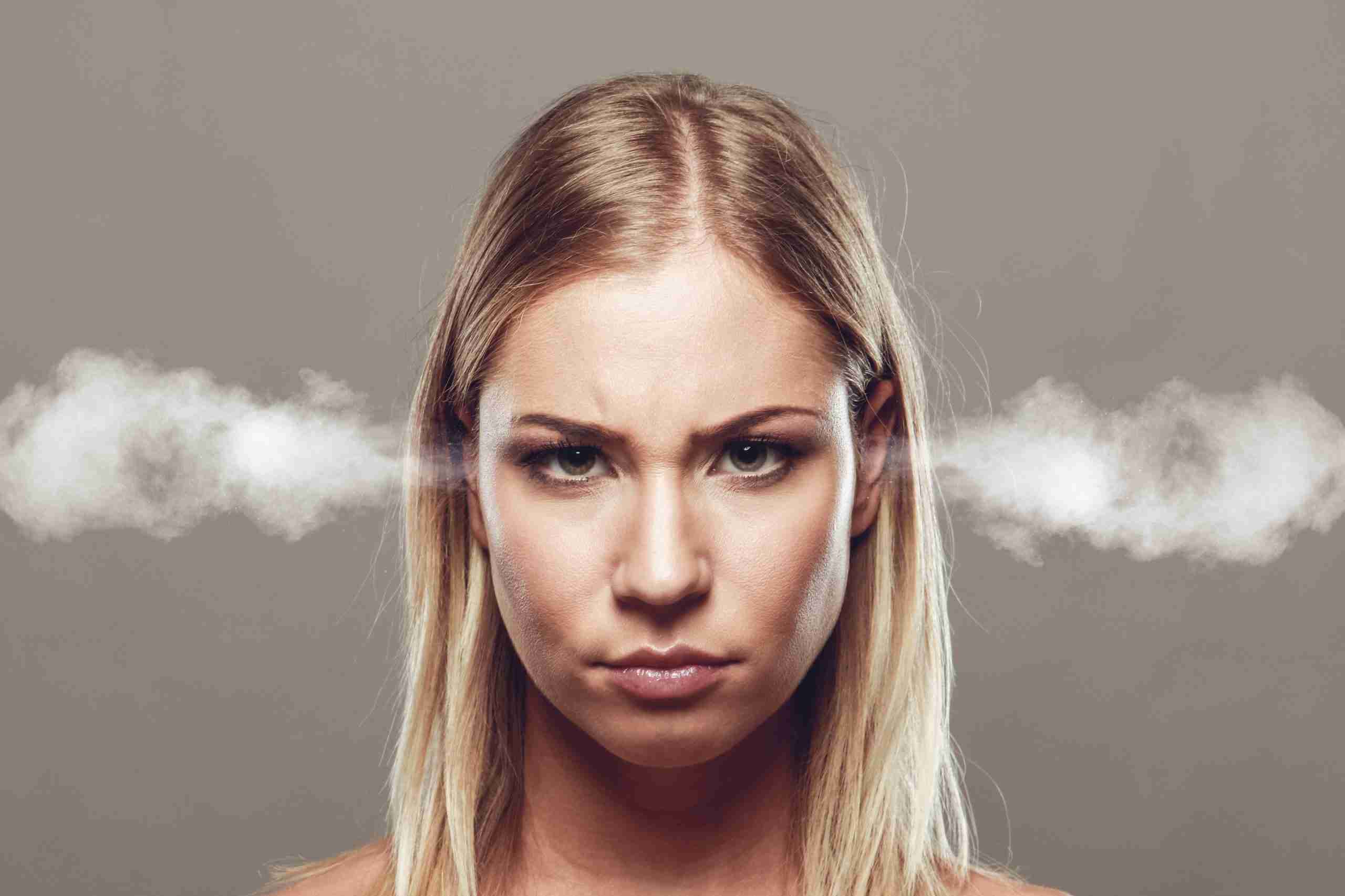
Come l’aglio per i vampiri.
Intendiamoci, dal lato statistico e concettuale, il criterio del “chi uccide chi” è utile in certi contesti. Lo vediamo oggi: quale malattia uccide di più un determinato tipo di persone? Oggi sappiamo che il covid uccide più anziani che giovani, grazie al criterio di rilevazione del “chi uccide chi”. Una riserva naturale si spopola di lepri: si osserva, si analizza e si scopre che sono le volpi a uccidere e mangiare specificamente le lepri, dunque il “chi uccide chi” ha un senso anche in etologia. Applicato agli esseri umani non ha quasi mai senso, anche perché non prende in considerazione il movente, che è cruciale in un atto omicidiario, e che virus e animali non hanno. L’unico senso che può avere per gli umani è per verificare se sia in atto una persecuzione di grandi proporzioni. Chi è che uccide tutti questi Tutsi in Ruanda? Gli Hutu. Chi è che uccide tutti questi ebrei in Germania? I nazisti. Chi è che uccide tutti questi indios in America? Gli europei colonizzatori. E così via. Altra utilità, se applicata agli umani, il criterio “chi uccide chi” non ne l’ha, ancor più se la sua applicazione porta alla registrazione di numeri microscopici. Ed è proprio questo il motivo per cui le statistiche pubbliche l’hanno adottato da poco più di dieci anni, quando il femminismo, con il suo interesse a dipingere le donne come vittime di una gigantesca e organizzata persecuzione maschile, ha iniziato a dettare la linea: far passare numeri microscopici per una persecuzione di massa.
Prima i due fenomeni si misuravano separatamente: quanti autori di omicidio? Tot uomini, tot donne; tot del nord, tot del sud; tot in questa o quella fascia d’età; tot ricchi e tot poveri, e così via. Fatto questo, si passava all’altra categoria: quante vittime di omicidio? Tot uomini, tot donne; tot del nord, tot del sud, eccetera. Il primo insieme di dati aiutava a capire se la devianza omicida si manifestava in specifiche aree sociali e/o geografiche, a prescindere dalle caratteristiche delle vittime, ed era utile per ipotizzare eventuali iniziative preventive o repressive circoscritte (esempio classico: la mafia, quando ancora era localizzata quasi solo al sud). Il secondo aiutava a capire se c’erano categorie più bersagliate, a prescindere dagli autori, e verso le quali dunque pensare strumenti di protezione. Ed è questo il motivo per cui, circa dagli anni 2000, hanno smesso di categorizzare così i dati e si sono votati al “chi uccide chi”: con il metodo vecchio risultava che la stragrande maggioranza di vittime di omicidio era composta da uomini, uccisi soprattutto da altri uomini e anche da qualche donna. La verità per cui gli uomini fossero e ancora siano le maggiori vittime di tutti è qualcosa che sovverte alla radice uno dei principali teoremi femministi. Roba da fare sulla pasionaria di turno l’effetto dell’aglio a un vampiro. Ebbene, tenetene conto, e quando durante un dibattito vi tirano fuori l’asso del “chi uccide chi”, ficcategli quell’aglio nelle narici e godetevi lo spettacolo.

