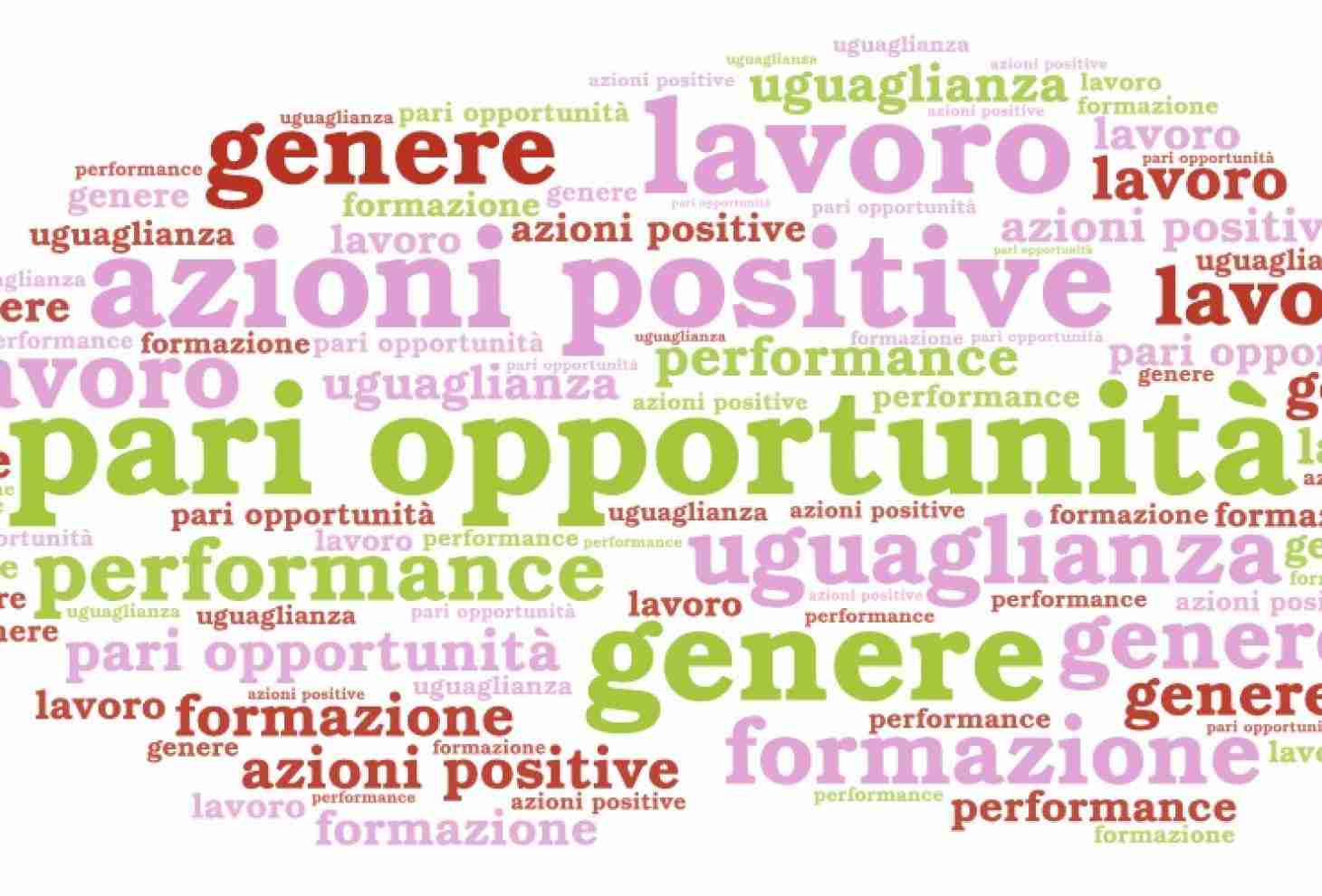Con il decreto legislativo 11/04/2006 nº 198 (G.U. 31/05/2006) sono state emanate una serie di disposizioni, note come “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”. Le disposizioni in esso contenute sono il prodotto di presupposti ideologici ben precisi, che vengono interamente recepiti nel nostro ordinamento. In questo articolo forniremo alcune valutazioni di carattere generale riguardo al contenuto di questo codice, rimandando a un elaborato più ampio e ai link contenuti in esso per la dimostrazione di come tali presupposti siano incardinati nella normativa in oggetto. Presupposti che, se esaminati criticamente, mostrano di non aver alcun fondamento razionale.
Il codice si articola in quattro parti: Libro I (artt. 1-22) Disposizioni per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna; Libro II (artt. 23-24) Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti etico-sociali; Libro III (artt. 25-55) Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti economici; Libro IV (artt. 56-58) Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti civili e politici. In tutti gli aspetti affrontati, si fa riferimento alla promozione e al raggiungimento delle “pari opportunità” tra uomo e donna: in realtà, a dispetto dei termini impiegati nella denominazione del codice stesso e delle sue parti, le finalità delle disposizioni contenute in esso rispondono esclusivamente alla determinazione di aumentare e favorire la presenza femminile nei vertici della piramide sociale, politica ed economica, e di porre in essere misure atte a realizzare condizioni di privilegio per le donne, prescindendo da ogni analisi comparata della relativa condizione maschile o da eventuali valutazioni inerenti alle capacità reddituali e lavorative dei singoli. Quindi non si tratta di “parità”, ma di promuovere solamente la parte femminile della popolazione, operando questa preferenza in base a un criterio sessuale, e di fare proprio, con questo intendimento, un totale appiattimento sulle tesi appartenenti all’ortodossia femminista.
Un sistema di incentivi divisivo e inaccettabile.
Seguendo la partizione del codice, e partendo dai rapporti etico-sociali oggetto del secondo libro, appare evidente che l’egoismo individualista di un genere abbia prevalso sul ruolo sociale, facendo venir meno la disponibilità a effettuare quelle rinunzie necessarie e inevitabili su cui si fonda la convivenza civile. La coesione sociale non si è spezzata a causa delle istanze di emancipazione della donna e in ragione del suo divenire lavoratrice, detentrice del potere di divorziare, abortire e, in sostanza, determinarsi: queste sono conquiste assodate, e non sono messe in discussione. Il patto sociale si è spezzato poiché si è accordata al femminile la possibilità di disconoscere il proprio ruolo e di non assolvere la propria funzione di attore sociale (mentre tali vincoli sono rimasti in capo al genere maschile). Per quanto riguarda i rapporti civili e politici, si rileva che gli apparati statali con cui i cittadini devono necessariamente rapportarsi non sono effettivamente dispensatori di un trattamento paritario in relazione al sesso del cittadino e tale giudizio è estendibile ai rapporti inerziali cittadino/Stato. L’attività del legislatore ha condizionato e condiziona questi rapporti, poiché il suo indirizzo è fortemente orientato verso una legislazione e una giurisprudenza in favore del sesso femminile, e questo ha creato di fatto una corsia preferenziale per i cittadini con discriminante sessuale. Da un lato, quindi, un’attività legislativa condizionata da un complesso riparatorio non del tutto ancorato alla realtà oggettiva e, dall’altro, la configurazione de facto di uno Stato non più in grado di trattare i suoi cittadini in maniera equa a prescindere dal loro sesso.
Per quanto concerne la materia dei rapporti economici, sempre sulla scia delle leggi e delle iniziative governative in favore del sesso femminile, si rileva un’evidente discriminazione dei cittadini in base al genere di appartenenza. Basta riferirsi a tutte quelle azioni concrete che, sotto l’ombrello ideologico delle “pari opportunità”, rendono disponibili capitali per fare impresa ai cittadini di sesso femminile, a condizioni di gran lunga migliori rispetto a quelle reperibili sul libero mercato finanziario da un cittadino di sesso maschile. Va rimarcato che spesso la reperibilità di capitali è determinante nell’avvio di una nuova impresa. È logica infantile comprendere che se il cittadino di sesso X e il cittadino di sesso Y hanno un’idea imprenditoriale e capitali insufficienti tali da rendere la partecipazione statale indispensabile per l’avvio d’impresa, e che se lo Stato attraverso una legge stabilisce di finanziare solo i cittadini di sesso Y, non si tratta di offrire alcuna “pari opportunità”, quanto, molto più concretamente, di favorire i cittadini di sesso Y nel creare impresa. Il tutto in un Paese con un tasso di disoccupazione al 9,7% ad agosto 2018, che coinvolge entrambe le componenti di genere. Secondo l’Istat, tuttavia, “ad agosto si stima un aumento degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,3%, pari a +46 mila unità). L’aumento coinvolge principalmente gli uomini e si distribuisce in tutte le classi di età ad eccezione dei 35-49enni. Il tasso di inattività sale al 34,5% (+0,1 punti percentuali).” Ciò rende l’attuale sistema di incentivi semplicemente inaccettabile nella sua essenza discriminatoria e divisiva.
Politiche non per la “parità” ma semplicemente femministe.
I termini “uguaglianza”, “discriminazione”, “genere”, “parità” compaiono sempre nella narrazione femminista (e in questo codice). Tuttavia, analizzando quelle situazioni per cui le femministe lamentano una condizione di oppressione subita dalle donne, una mancanza di parità o di opportunità per le donne, si vedrà che esse non reggono ad alcun vaglio di analisi storica, filosofica, logico-razionale. Se le tesi della ideologia femminista sono prive di fondamento, perché insistere su termini quali “parità”, “discriminazione”, “azioni positive”? Semplice. Il femminismo non può presentare apertamente le proprie istanze come le rivendicazioni di privilegi, deve necessariamente universalizzare le proprie richieste, ovvero ricorrere a termini che facciano riferimento a valori universali e al tempo stesso instillare nelle coscienze l’idea che i presupposti che legittimano il ricorso a questi termini siano fondati. Qui si gioca uno dei punti fondamentali del discorso. Il femminismo tende pervicacemente a sottrarre alla prassi argomentativa le proprie tesi. Se è infatti pienamente condivisibile l’idea che le verità morali si generino nei discorsi pratici (pubblici e privati), il femminismo sottrae il riconoscimento intersoggettivo sulla validità morale delle proprie norme al confronto tra argomentazioni. Il mezzo attraverso il quale esso vuole imporsi come teoria dominante non è l’affidamento alla forza argomentativa migliore (unica via che lega l’universalizzazione di una norma morale all’ottenimento dell’approvazione di tutti i soggetti coinvolti nel discorso pratico), ma l’imposizione delle proprie tesi mediante l’esclusione dal dialogo di quei soggetti che manifestino interessi contrari alla propria. Attraverso tale esclusione “assiomatica” di una parte dei soggetti interessati alla formazione della norma fondamentale (“l’uguaglianza”, “la parità”), esso perviene, a dispetto della formulazione universale, ad un’applicazione monologica del principio in oggetto (“parità”, “rimozione delle discriminazioni”).
Un esempio è nel codice stesso e nell’esclusione delle associazioni maschili dalla formazione della commissione e del comitato anzidetti. Ecco così che il Ministero per le Pari Opportunità non spende una parola sul dramma dei suicidi maschili, ignora ogni richiesta di ascolto o ogni tavolo di confronto con i soggetti che non appartengono all’associazionismo femminista, al rimbalzo tra “parità” e “lavoro delle donne”, alla sottoposizione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro all’adempimento delle richieste delle consigliere e dei consiglieri (che non ci sono, visto che il potere dell’associazionismo femminista è tale da aver ottenuto la nomina di 240 consigliere su 240 posti disponibili, alla faccia della “parità di genere” e della “pari rappresentatività”). Da tutto questo si può desumere che la continua espressione di politiche in favore di uno e uno solo genere sessuale (e non di rado messe in atto a discapito del genere antagonista), e la conseguente, assecondante legiferazione, hanno condotto alla configurazione golemica di uno Stato sessualmente caratterizzato, dotando l’apparato pubblico di una propria identità di genere: non si corre in errore, oggi, dicendo che lo Stato Italiano, istituzionalmente, sia di genere femminista. Che la promulgazione di leggi in favore di un genere sessuale, seppur in teoria motivata alla base da intenti condivisibili (se, e solo se, le motivazioni di innesco fossero ancorate alla realtà), si sia rivelata un’arma a doppio taglio risulta solare dai dati che abbiamo a disposizione oltre che dalla versione allargata dell’analisi di questa tematica. Appare paradossale pertanto che nel modello sociale attuale il maschio, che avrebbe le motivazioni per esprimere logiche istanze di rivendicazione di genere, venga ostracizzato dal genere femminile ed accusato di essere parte di un patriarcato che nei fatti si rivela inesistente. Tali politiche quindi non promuovo la parità tra i generi, ma l’applicazione dell’ideologia femminista.